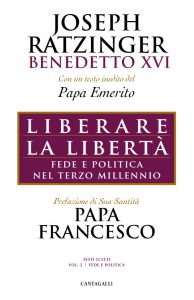Contributi sulla famiglia
Pubblichiamo la prefazione scritta da Papa Franceso al libro che raccoglie gli scritti del Pontefice emerito Benedetto XVI su fede e politica: Liberare la libertà. Fede e politica nel terzo millennio. (Editrice Cantagalli).
Il rapporto tra fede e politica è uno dei grandi temi da sempre al centro dell’attenzione di Joseph Ratzinger/Benedetto XVI e attraversa l’intero suo cammino intellettuale e umano: l’esperienza diretta del totalitarismo nazista lo porta sin da giovane studioso a riflettere sui limiti dell’obbedienza allo Stato a favore della libertà dell’obbedienza a Dio: «Lo Stato – scrive in questo senso in uno dei testi proposti – non è la totalità dell’esistenza umana e non abbraccia tutta la speranza umana.
L’uomo e la sua speranza vanno oltre la realtà dello Stato e oltre la sfera dell’azione politica. Ciò vale non solo per uno Stato che si chiama Babilonia, ma per ogni genere di Stato. Lo Stato non è la totalità. Questo alleggerisce il peso all’uomo politico e gli apre la strada a una politica razionale. Lo Stato romano era falso e anticristiano proprio perché voleva essere il totum delle possibilità e delle speranze umane. Così esso pretende ciò che non può; così falsifica ed impoverisce l’uomo. Con la sua menzogna totalitaria diventa demoniaco e tirannico».
Successivamente, anche proprio su questa base, a fianco di San Giovanni Paolo II egli elabora e propone una visione cristiana dei diritti umani capace di mettere in discussione a livello teorico e pratico la pretesa totalitaria dello Stato marxista e dell’ideologia atea sulla quale si fondava.
Perché l’autentico contrasto tra marxismo e cristianesimo per Ratzinger non è certo dato dall’attenzione preferenziale del cristiano per i poveri: «Dobbiamo imparare – ancora una volta, non solo a livello teorico, ma nel modo di pensare e di agire – che accanto alla presenza reale di Gesù nella Chiesa e nel sacramento, esiste quell’altra presenza reale di Gesù nei più piccoli, nei calpestati di questo mondo, negli ultimi, nei quali egli vuole essere trovato da noi» scrive Ratzinger già negli anni Settanta con una profondità teologica e insieme immediata accessibilità che sono proprie del pastore autentico. E quel contrasto non è dato nemmeno, come egli sottolinea alla metà degli anni Ottanta, dalla mancanza nel Magistero della Chiesa del senso di equità e solidarietà; e, di conseguenza, «nella denuncia dello scandalo delle palesi disuguaglianze tra ricchi e poveri – si tratti di disuguaglianze tra paesi ricchi e paesi poveri oppure di disuguaglianze tra ceti sociali nell’ambito dello stesso territorio nazionale che non è più tollerato».
Il profondo contrasto, nota Ratzinger, è dato invece – e prima ancora che dalla pretesa marxista di collocare il cielo sulla terra, la redenzione dell’uomo nell’aldiquà– dalla differenza abissale che sussiste riguardo al come la redenzione debba avvenire: «La redenzione avviene per mezzo della liberazione da ogni dipendenza, oppure l’unica via che porta alla liberazione è la completa dipendenza dall’amore, dipendenza che sarebbe poi anche la vera libertà?».
E così, con un salto di trent’anni, egli ci accompagna alla comprensione del nostro presente, a testimonianza dell’immutata freschezza e vitalità del suo pensiero. Oggi infatti, più che mai, si ripropone la medesima tentazione del rifiuto di ogni dipendenza dall’amore che non sia l’amore dell’uomo per il proprio ego, per «l’io e le sue voglie»; e, di conseguenza, il pericolo della «colonizzazione» delle coscienze da parte di una ideologia che nega la certezza di fondo per cui l’uomo esiste come maschio e femmina ai quali è assegnato il compito della trasmissione della vita; quell’ideologia che arriva alla produzione pianificata e razionale di esseri umani e che – magari per qualche fine considerato «buono» – arriva a ritenere logico e lecito eliminare quello che non si considera più creato, donato, concepito e generato ma fatto da noi stessi.
Questi apparenti «diritti» umani che sono tutti orientati all’autodistruzione dell’uomo – questo ci mostra con forza ed efficacia Joseph Ratzinger – hanno un unico comune denominatore che consiste in un’unica, grande negazione: la negazione della dipendenza dall’amore, la negazione che l’uomo è creatura di Dio, fatto amorevolmente da Lui a Sua immagine e a cui l’uomo anela come la cerva ai corsi d’acqua (Sal 41). Quando si nega questa dipendenza tra creatura e creatore, questa relazione d’amore, si rinuncia in fondo alla vera grandezza dell’uomo, al baluardo della sua libertà e dignità.
Così la difesa dell’uomo e dell’umano contro le riduzioni ideologiche del potere passa oggi ancora una volta dal fissare l’obbedienza dell’uomo a Dio quale limite dell’obbedienza allo Stato. Raccogliere questa sfida, nel vero e proprio cambio d’epoca in cui oggi viviamo, significa difendere la famiglia. D’altronde già San Giovanni Paolo II aveva ben compreso la portata decisiva della questione: a ragione chiamato anche il «Papa della famiglia», non a caso sottolineava che «l’avvenire dell’umanità passa attraverso la famiglia» (Familiaris consortio, 86). E su questa linea anche io ho ribadito che «il bene della famiglia è decisivo per il futuro del mondo e della Chiesa» (Amoris laetitia, 31).
Così sono particolarmente lieto di potere introdurre questo secondo volume dei testi scelti di Joseph Ratzinger sul tema «fede e politica». Insieme alla sua poderosa Opera omnia, essi possono aiutare non solo tutti noi a comprendere il nostro presente e a trovare un solido orientamento per il futuro, ma anche essere vera e propria fonte d’ispirazione per un’azione politica che, ponendo la famiglia, la solidarietà e l’equità al centro della sua attenzione e della sua programmazione, veramente guardi al futuro con lungimiranza.
____________
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA XLIX GIORNATA MONDIALE
DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI
Comunicare la famiglia:
ambiente privilegiato dell’incontro nella gratuità dell’amore
Il tema della famiglia è al centro di un’approfondita riflessione ecclesiale e di un processo sinodale che prevede due Sinodi, uno straordinario – appena celebrato – ed uno ordinario, convocato per il prossimo ottobre. In tale contesto, ho ritenuto opportuno che il tema della prossima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali avesse come punto di riferimento la famiglia. La famiglia è del resto il primo luogo dove impariamo a comunicare. Tornare a questo momento originario ci può aiutare sia a rendere la comunicazione più autentica e umana, sia a guardare la famiglia da un nuovo punto di vista.
Possiamo lasciarci ispirare dall’icona evangelica della visita di Maria ad Elisabetta (Lc 1,39-56). «Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!”» (vv. 41-42).
Anzitutto, questo episodio ci mostra la comunicazione come un dialogo che si intreccia con il linguaggio del corpo. La prima risposta al saluto di Maria la dà infatti il bambino, sussultando gioiosamente nel grembo di Elisabetta. Esultare per la gioia dell’incontro è in un certo senso l’archetipo e il simbolo di ogni altra comunicazione, che impariamo ancora prima di venire al mondo. Il grembo che ci ospita è la prima “scuola” di comunicazione, fatta di ascolto e di contatto corporeo, dove cominciamo a familiarizzare col mondo esterno in un ambiente protetto e al suono rassicurante del battito del cuore della mamma. Questo incontro tra due esseri insieme così intimi e ancora così estranei l’uno all’altra, un incontro pieno di promesse, è la nostra prima esperienza di comunicazione. Ed è un’esperienza che ci accomuna tutti, perché ciascuno di noi è nato da una madre.
Anche dopo essere venuti al mondo restiamo in un certo senso in un “grembo”, che è la famiglia. Un grembo fatto di persone diverse, in relazione: la famiglia è il «luogo dove si impara a convivere nella differenza» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 66). Differenze di generi e di generazioni, che comunicano prima di tutto perché si accolgono a vicenda, perché tra loro esiste un vincolo. E più largo è il ventaglio di queste relazioni, più sono diverse le età, e più ricco è il nostro ambiente di vita. È il legame che sta a fondamento della parola, che a sua volta rinsalda il legame. Le parole non le inventiamo: le possiamo usare perché le abbiamo ricevute. E’ in famiglia che si impara a parlare nella “lingua materna”, cioè la lingua dei nostri antenati (cfr 2 Mac 7,25.27). In famiglia si percepisce che altri ci hanno preceduto, ci hanno messo nella condizione di esistere e di potere a nostra volta generare vita e fare qualcosa di buono e di bello. Possiamo dare perché abbiamo ricevuto, e questo circuito virtuoso sta al cuore della capacità della famiglia di comunicarsi e di comunicare; e, più in generale, è il paradigma di ogni comunicazione.
L’esperienza del legame che ci “precede” fa sì che la famiglia sia anche il contesto in cui si trasmette quella forma fondamentale di comunicazione che è la preghiera. Quando la mamma e il papà fanno addormentare i loro bambini appena nati, molto spesso li affidano a Dio, perché vegli su di essi; e quando sono un po’ più grandi recitano insieme con loro semplici preghiere, ricordando con affetto anche altre persone, i nonni, altri parenti, i malati e i sofferenti, tutti coloro che hanno più bisogno dell’aiuto di Dio. Così, in famiglia, la maggior parte di noi ha imparato la dimensione religiosa della comunicazione, che nel cristianesimo è tutta impregnata di amore, l’amore di Dio che si dona a noi e che noi offriamo agli altri.
Nella famiglia è soprattutto la capacità di abbracciarsi, sostenersi, accompagnarsi, decifrare gli sguardi e i silenzi, ridere e piangere insieme, tra persone che non si sono scelte e tuttavia sono così importanti l’una per l’altra, a farci capire che cosa è veramente la comunicazione come scoperta e costruzione di prossimità. Ridurre le distanze, venendosi incontro a vicenda e accogliendosi, è motivo di gratitudine e gioia: dal saluto di Maria e dal sussulto del bambino scaturisce la benedizione di Elisabetta, a cui segue il bellissimo cantico del Magnificat, nel quale Maria loda il disegno d’amore di Dio su di lei e sul suo popolo. Da un “sì” pronunciato con fede scaturiscono conseguenze che vanno ben oltre noi stessi e si espandono nel mondo. “Visitare” comporta aprire le porte, non rinchiudersi nei propri appartamenti, uscire, andare verso l’altro. Anche la famiglia è viva se respira aprendosi oltre sé stessa, e le famiglie che fanno questo possono comunicare il loro messaggio di vita e di comunione, possono dare conforto e speranza alle famiglie più ferite, e far crescere la Chiesa stessa, che è famiglia di famiglie.
La famiglia è più di ogni altro il luogo in cui, vivendo insieme nella quotidianità, si sperimentano i limiti propri e altrui, i piccoli e grandi problemi della coesistenza, dell’andare d’accordo. Non esiste la famiglia perfetta, ma non bisogna avere paura dell’imperfezione, della fragilità, nemmeno dei conflitti; bisogna imparare ad affrontarli in maniera costruttiva. Per questo la famiglia in cui, con i propri limiti e peccati, ci si vuole bene, diventa una scuola di perdono. Il perdono è una dinamica di comunicazione, una comunicazione che si logora, che si spezza e che, attraverso il pentimento espresso e accolto, si può riannodare e far crescere. Un bambino che in famiglia impara ad ascoltare gli altri, a parlare in modo rispettoso, esprimendo il proprio punto di vista senza negare quello altrui, sarà nella società un costruttore di dialogo e di riconciliazione.
A proposito di limiti e comunicazione, hanno tanto da insegnarci le famiglie con figli segnati da una o più disabilità. Il deficit motorio, sensoriale o intellettivo è sempre una tentazione a chiudersi; ma può diventare, grazie all’amore dei genitori, dei fratelli e di altre persone amiche, uno stimolo ad aprirsi, a condividere, a comunicare in modo inclusivo; e può aiutare la scuola, la parrocchia, le associazioni a diventare più accoglienti verso tutti, a non escludere nessuno.
In un mondo, poi, dove così spesso si maledice, si parla male, si semina zizzania, si inquina con le chiacchiere il nostro ambiente umano, la famiglia può essere una scuola di comunicazione come benedizione. E questo anche là dove sembra prevalere l’inevitabilità dell’odio e della violenza, quando le famiglie sono separate tra loro da muri di pietra o dai muri non meno impenetrabili del pregiudizio e del risentimento, quando sembrano esserci buone ragioni per dire “adesso basta”; in realtà, benedire anziché maledire, visitare anziché respingere, accogliere anziché combattere è l’unico modo per spezzare la spirale del male, per testimoniare che il bene è sempre possibile, per educare i figli alla fratellanza.
Oggi i media più moderni, che soprattutto per i più giovani sono ormai irrinunciabili, possono sia ostacolare che aiutare la comunicazione in famiglia e tra famiglie. La possono ostacolare se diventano un modo di sottrarsi all’ascolto, di isolarsi dalla compresenza fisica, con la saturazione di ogni momento di silenzio e di attesa disimparando che «il silenzio è parte integrante della comunicazione e senza di esso non esistono parole dense di contenuto» (Benedetto XVI, Messaggio per la 46ª G.M. delle Comunicazioni Sociali, 24.1.2012). La possono favorire se aiutano a raccontare e condividere, a restare in contatto con i lontani, a ringraziare e chiedere perdono, a rendere sempre di nuovo possibile l’incontro. Riscoprendo quotidianamente questo centro vitale che è l’incontro, questo “inizio vivo”, noi sapremo orientare il nostro rapporto con le tecnologie, invece che farci guidare da esse. Anche in questo campo, i genitori sono i primi educatori. Ma non vanno lasciati soli; la comunità cristiana è chiamata ad affiancarli perché sappiano insegnare ai figli a vivere nell’ambiente comunicativo secondo i criteri della dignità della persona umana e del bene comune.
La sfida che oggi ci si presenta è, dunque, reimparare a raccontare, non semplicemente a produrre e consumare informazione. E’ questa la direzione verso cui ci spingono i potenti e preziosi mezzi della comunicazione contemporanea. L’informazione è importante ma non basta, perché troppo spesso semplifica, contrappone le differenze e le visioni diverse sollecitando a schierarsi per l’una o l’altra, anziché favorire uno sguardo d’insieme.
Anche la famiglia, in conclusione, non è un oggetto sul quale si comunicano delle opinioni o un terreno sul quale combattere battaglie ideologiche, ma un ambiente in cui si impara a comunicare nella prossimità e un soggetto che comunica, una “comunità comunicante”. Una comunità che sa accompagnare, festeggiare e fruttificare. In questo senso è possibile ripristinare uno sguardo capace di riconoscere che la famiglia continua ad essere una grande risorsa, e non solo un problema o un’istituzione in crisi. I media tendono a volte a presentare la famiglia come se fosse un modello astratto da accettare o rifiutare, da difendere o attaccare, invece che una realtà concreta da vivere; o come se fosse un’ideologia di qualcuno contro qualcun altro, invece che il luogo dove tutti impariamo che cosa significa comunicare nell’amore ricevuto e donato. Raccontare significa invece comprendere che le nostre vite sono intrecciate in una trama unitaria, che le voci sono molteplici e ciascuna è insostituibile.
La famiglia più bella, protagonista e non problema, è quella che sa comunicare, partendo dalla testimonianza, la bellezza e la ricchezza del rapporto tra uomo e donna, e di quello tra genitori e figli. Non lottiamo per difendere il passato, ma lavoriamo con pazienza e fiducia, in tutti gli ambienti che quotidianamente abitiamo, per costruire il futuro.
Dal Vaticano, 23 gennaio 2015
Vigilia della festa di san Francesco di Sales
Francesco
La famiglia che prega, custodisce la fede e vive la gioia
Omelia del Papa per la Giornata della Famiglia
47a Settimana Sociale dei Cattolici Italiani
La famiglia, speranza e futuro per la società italiana
Torino, 12-15 settembre 2013
L’architettura della famiglia: logica e ricadute sociali
Prolusione di S.Em. Card. Angelo Bagnasco
Arcivescovo di Genova e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
Giovedì 12 settembre 2013
1. In ascolto dell’uomo e della donna di oggi
“Da ogni parte ci esortavano a salvare il pianeta. Non si doveva, con la stessa urgenza, venire in soccorso all’umano? Se l’aria doveva restare pura, se l’erba doveva restare verde, non bisognava anche che il mondo degli umani restasse abitabile? Che cosa si faceva della terra degli uomini?”[1]. A questa domanda intende rispondere in un suo recente saggio, la psichiatra Catherine Ternynck, che guida il lettore a decifrare cosa stia accadendo alla nostra generazione, soggetta a sempre più frequenti crisi depressive e a inedite forme di disagio sociale. Si tratta del suolo umano che si è impoverito, si è svuotato del suo humus di relazioni, legami, responsabilità e così è divenuto friabile ed inconsistente. Al punto che l’uomo stesso, su questo terreno incerto, finisce per diventare ‘di sabbia’, una figura fluida, impastata di contraddizioni e con una caratteristica evidente: la sensazione di stanchezza. È un uomo ‘dalla testa pesante’ che fatica a portare avanti la sua vita, dubita del tragitto e del senso, chiedendo al contempo riconoscimento e rassicurazione. È schiacciato dall’urgenza di farsi da sé in una competizione continua, e nello stesso tempo scopre che gli manca la terra sotto i piedi. Il grande sogno dell’individualismo, che ha segnato di sé l’uomo moderno, lo ha condotto nella post-modernità ad una imbarazzante scoperta: il grande sogno non ha tenuto!
Anche noi, in questi giorni, vorremmo insieme provare ad ascoltare l’uomo e la donna di oggi, senza pregiudizi o filtri ideologici, ma assecondando la vocazione della Chiesa che ha come suo primo compito quello di ascoltare Dio e inseparabilmente il mondo, soprattutto le sue sofferenze, disagi e fatiche, le sue paure. L’obiettivo non è di difendere una posizione, di ribadire un principio, ma di portare a credenti e non credenti il contributo di umanizzazione che la luce della fede suscita innanzitutto nell’ambito della famiglia, come ci ha ricordato di recente Papa Francesco[2]. Tra i luoghi deteriorati dall’individualismo, laddove sono custodite le fondamenta dell’umanità, c’è la famiglia, ancor prima del sociale e del politico. È diventato perfino uno slogan dire che essa è in crisi, e indicatori severi non mancano al riguardo. La famiglia tuttavia è pure l’antidoto alla stessa crisi, l’unica alternativa praticabile ad una esasperazione dell’individuo, la cui pesantezza è diventata insostenibile sotto l’imperativo di un’autonomia rivelatasi ben presto ingenua e cinica allo stesso tempo.
Interrogandoci sulla famiglia, con l’apporto di competenze qualificate e plurali, continua e si sviluppa quella correlazione tra Vangelo e società, che nel nostro Paese vanta una esperienza più che secolare, e che oggi si apre qui a Torino con la 47ª Settimana Sociale dei Cattolici. Come rilevava la NotaCEIdel 1988 infatti: “Le Settimane Sociali, (…) saranno espressione della diaconia della Chiesa italiana al Paese, che vive un complesso momento storico di trasformazione per certi versi ricco e positivo e per altri incerto e problematico. Una diaconia culturale che si eserciterà con un costruttivo senso del dialogo e del confronto nel pieno rispetto della verità e della carità cristiana”[3]. Il nostro vuol essere, dunque, un servizio al dibattito culturale in corso nel nostro Paese, e per questo un confronto serio e rigoroso, aperto al contributo di tutti gli uomini pensosi, capaci di lasciarsi interrogare dalla famiglia che non è una ‘invenzione stagionale’[4], e come tale soggetta a cicliche ridefinizioni. Senza dimenticare per altro che essa richiede di essere sempre di nuovo compresa nella sua architettura essenziale.
La riflessione che stiamo per affrontare, si snoderà attraverso un primo tornante che cerca di mettere a fuoco un elemento specifico del familiare nella relazione tra generi diversi e tra diverse generazioni, con le implicazioni che ne derivano. La roccia della differenza è fondamentale per ritessere l’umano che rischia diversamente di essere polverizzato in un indistinto egualitarismo che cancella la differenza sessuale e quella generazionale, eliminando così la possibilità di essere padre e madre, figlio e figlia. In un secondo momento si cercherà di ricavare le conseguenze che sul piano sociale ed economico debbono essere tratte al più presto, perché la famiglia non resti imbrigliata in immagini stereotipate o in utopiche fughe in avanti. In conclusione spero sarà più chiaro che la famiglia è una risorsa e non un ostacolo alla modernizzazione, anzi la speranza e, dunque, il futuro.
La domanda che resta alla fine non è quella che risuona frequentemente: “Che mondo lasceremo ai nostri figli?”; ma una più inquietante: “A quali figli lasceremo il mondo?”.
- 2. La relazione tra generi diversi e tra diverse generazioni
La differenza dei sessi e la differenza delle generazioni costituiscono la travatura di ogni essere umano, l’espressione visibile e certa del suo essere relazione, due orientamenti fondamentali che non possono essere confusi senza che ne segua una disorganizzazione globale della persona e della società. Il fatto è che, nel volgere di qualche decennio, una tale persuasione ha perso di evidenza ed è diventata un problema. Come siamo arrivati a questo punto? E soprattutto chi ha paura della differenza? Bisogna prendere coscienza di almeno due processi culturali. Il primo è il rilievo sociale della sessualità che ha prodotto paradossalmente l’eclissi dell’identità sessuata; il secondo è la caduta verticale del dialogo tra le generazioni che sembra portare al congedo dalla possibilità stessa di educare.
Quanto al primo processo, a partire dagli anni ’70 si fa strada l’idea che il sesso non sia semplicemente un dato biologico, ma che comporti una elaborazione culturale in funzione della ripartizione dei ruoli nella società di appartenenza. Questo è quanto in un primo tempo la gender theory sostiene. Infatti, a partire dalla celebre espressione di Simone de Beauvoir – “Non si nasce donna, lo si diventa” – si comincia a distinguere il sesso dal genere, come due realtà non sovrapponibili. Sulla prima, biologica, storicamente si sarebbe innestata la seconda, con una crescente valenza culturale e sociale e quindi politica. Infatti, la categoria “genere” nel tempo è venuta a significare rappresentazioni e ruoli che sono stati considerati ‘naturali’, e che invece, la critica femminista prima e la riflessione culturale dopo, ritengono sovrapposizioni per nulla naturali, ma piuttosto funzionali a posizioni di potere maschile. Basta pensare alla posizioni culturale e sociale della donna in alcune epoche o aree geografiche, dove la sua libertà, il diritto all’istruzione, il desiderio di contribuire alla vita sociale, non sono state o non sono ancora adeguatamente riconosciuti. Questo sforzo di comprensione e critica è non solo legittimo, ma anche opportuno. Semmai, oggi, bisognerebbe smascherare talune immagini di apparente liberazione della donna che, in realtà, ripropongono nuove e più sottili forme di subordinazione al riconoscimento maschile.
La messa in questione del ‘dato per scontato’ ha prodotto esiti diversi. Da una parte, in termini generali, una maggiore consapevolezza della propria sessualità, e dall’altra l’estremizzazione della propria libertà, quasi scatenando una specie di sospetto e di pregiudiziale iconoclasta verso tutto ciò che socialmente sembrava essere legato alla differenza sessuale. La categoria di “genere” divenne così sempre più autonoma rispetto alla categorie di “sesso biologico”, fino a separarsi e a contrapporsi rivendicando un’autonomia assoluta, dichiarando la fine del “dato naturale” e instaurando il primato del “culturale”, della cifra “storica”, della preferenza soggettiva, individuale. Volendo eliminare dalla dimensione sessuale le sovrastrutture socio-culturali espresse con la categoria di “genere”, si è giunti a negare anche il dato di partenza: la persona nasce sessuata. Come appare, il concetto ha così subito una radicale mutazione fino ad esprimere “l’autopercezione individuale”: come il soggetto si percepisce, egli è. Si è venuti a decostruire la dimensione sessuale fino ad adeguarla alla liquidità sociale (Z. Bauman). Dobbiamo uscire da quello che Havel efficacemente definiva ‘l’esilio del privato’, e avere l’umiltà e il coraggio di riconoscere che le nostre scelte non sono solo ‘affare nostro’, ma che contribuiscono a contenere o aggravare i problemi dell’ambiente fisico, a costruire o disgregare il mondo sociale. Restringere l’orizzonte su ciò che ci va di fare, che ci fa ‘stare bene’, senza altre considerazioni (il senso, il bene di altri, la gratitudine per ciò che si è ricevuto, le generazioni presenti e future…) significa mortificare, non liberare, la nostra umanità.
Tale capovolgimento dall’oggettivo al soggettivo, dalla natura alla cultura, non è limitato alla dimensione della sessualità, ma rientra in una visione ben più ampia che tocca la stessa visione antropologica: la persona stessa – nella sua complessità – è considerata come risultato mutevole della storia, anziché un dato oggettivo e imprescindibile da cui partire e da tenere come criterio che guida lo sviluppo personale e sociale.
In uno dei saggi che hanno fatto opinione si legge, non senza sorpresa: “Teorizzando che il genere è una costruzione sociale del tutto indipendente dal sesso, il genere stesso diventa un artificio libero da vincoli. Di conseguenza, uomo e maschile potrebbero riferirsi sia a un corpo femminile sia a uno maschile; donna e femminile, sia a un corpo maschile sia a uno femminile”[5].
Questa prospettiva fortemente reattiva alla tradizione e insofferente a qualunque vincolo per l’espansione illimitata dell’io, presenta gli stessi limiti dell’individualismo assoluto, che già da tempo si sta dimostrando una prospettiva antropologica inadeguata a realizzare le aspettative di felicità e libertà che aveva acceso[6]. Ma, ancor più gravemente, sta facendo emergere il carico di violenza che la prospettiva autoreferenziale, insofferente ai legami, porta con sé, come i drammatici casi di cronaca sempre più numerosi testimoniano.
Una riflessione seria e rigorosa, che sia improntata non a una teoria dell’equivalenza ma alla ricchezza insostituibile della differenza, è dunque oggi quanto mai opportuna e necessaria, e da cattolici si può dare un contributo ad un dibattito che rischia di essere monotematico. Quando, ad esempio, attraverso una decisione politica, vengono giuridicamente equiparate forme di vita in se stesse differenti – come la relazione tra l’uomo e la donna e quella tra due persone dello stesso sesso – si misconosce la specificità della famiglia e se ne preclude l’autentica valorizzazione nel contesto sociale, trattando in modo uguale realtà diverse. Si appiattisce così il concetto di uguaglianza, che non consiste nel dare a tutti la stessa cosa, ma nel dare a ognuno ciò che gli è coerente: “La famiglia non può essere umiliata e modellata da rappresentazioni similari che in modo felpato costituiscono un ‘vulnus’ progressivo alla sua specifica identità e che non sono necessarie per tutelare diritti individuali in larga misura già garantiti dall’ordinamento”[7].
Frequentemente ci si oppone alle ragionevoli considerazioni della Chiesa per motivi ideologici. Nei mesi scorsi, il dibattito sulla legge contro l’omofobia ha manifestato con chiarezza questa tendenza. Nessuno discute il crimine e l’odiosità della violenza contro ogni persona, qualunque ne sia il motivo: tale decisa e codificata condanna – coniugata con una costante azione educativa – dovrebbe essere sufficiente in una società civile. In ogni caso, per lo stesso senso di civiltà, nessuno dovrebbe discriminare, né tanto meno poter incriminare in alcun modo, chi sostenga pubblicamente ad esempio che la famiglia è solo quella tra un uomo e una donna[8] fondata sul matrimonio, o che la dimensione sessuata è un fatto di natura e non di cultura.
Il secondo processo che ha gradualmente segnata l’esperienza della famiglia è l’oscuramento della differenza tra le generazioni e, quando in un ambiente non vi è luce, o ci si allontana o ci si scontra. Tale messa tra parentesi oggi porta ad una sorta di ‘segregazione generazionale’, per cui sembra che tra adulti e giovani sia diventato impossibile parlarsi e ancora prima ascoltarsi. Colpiti da una forma di reciproco autismo e indifferenza, diventa sempre più difficile pensare ad un’origine comune, ciascuno tendendo a vivere il suo segmento di presente come se fosse l’unica cosa che conta, l’unica certezza. A questo riguardo, è stato notato che il fatto di nascere da qualcuno appare – ancor più che la censura della morte – l’autentica rimozione della nostra epoca. In effetti, quello che manca è la percezione di pro-venire da altro e di non essere autosufficienti, auto-fondanti. Significativamente, nel processo di secolarizzazione, l’essere umano pretende di trasferire su se stesso gli attributi di Dio, dimenticando però il più importante: l’essere di Dio è esserci per gli altri, è generare, è Amore[9].
Al tema della generazione e dell’origine si collega strettamente quello dell’autorità. Non a caso, la crisi di quest’ultima si è manifestata in quella ‘morte del padre’ che ha caratterizzato, a partire dal ’68, le società occidentali, ridefinendo le coordinate dei rapporti non solo all’interno della famiglia, ma anche della scuola, della Chiesa, dell’intera società. Il motivo del rifiuto dell’autorità è che essa viene sistematicamente confusa con il potere, di cui si ha una concezione pregiudizialmente negativa come imposizione e arbitrio. In generale, l’autorità è chiamata ad essere punto di riferimento per gli altri, deve discernere il bene comune, decidere in modo obbligante. Nessuna autorità è per affermare se stessa, ma sempre e solo per servire gli altri: in famiglia, in società, nella Chiesa. Sul piano educativo, poi, chi ha autorità deve acquisire in modo speciale quella autorevolezza che deriva dalla personale coerenza, dall’avere qualcosa di vero e di grande da dire, dal riconoscere il proprio ruolo, dal giocarsi in prima persona sapendo che educando gli altri educa se stesso. Per questo è ascoltato, perché ascoltandolo ci si sente crescere.
Ci vogliono dunque adulti che siano interiormente maturi, che non giochino con il mito dell’eterna giovinezza; che non si pongano in patetica concorrenza con i propri figli; che siano visibilmente lieti della loro età; consapevoli del doversi far carico perché altri si aprano responsabilmente alla loro vita. I genitori – a titolo specialissimo – devono accendere nei figli l’uomo spirituale e morale; devono generare l’uomo del corpo ma anche dell’anima; devono condurre la persona oltre se stessa per introdurla alla realtà intera, consci che – per dirla con Romano Guardini – “l’educatore deve aver ben chiaro al riguardo che la massima efficacia non viene da come egli parla, bensì da ciò che egli stesso è e fa. Questo crea l’atmosfera; e il fanciullo, che non riflette o riflette poco, è soprattutto ricettivo all’atmosfera. Si può dire che il primo fattore è ciò che l’educatore è; il secondo è ciò che l’educatore fa; solo il terzo, ciò che egli dice”[10].
Mi ha colpito, nella recente GMG di Rio, l’invito ripetuto di Papa Francesco a ristabilire il dialogo tra giovani ed anziani che, a suo dire, sono i due estremi della società che rischiano di essere scartati. Gli anziani sono «importanti nella vita della famiglia per comunicare quel patrimonio di umanità e di fede che è essenziale per ogni società»[11]. Invece, non di rado sono trattati come un peso, anziché essere considerati il più grande bagaglio di conoscenze e saggezza. Essi sono visti non di rado come una spesa magari da contenere o ridurre con provvedimenti disumani seppure mascherati come libertà individuale e pietà sociale. A loro volta gli anziani, almeno quelli attivi, rischiano di assimilare una mentalità individualistica, e faticano a fare spazio ai giovani, oppure si ripiegano sulla dimensione privata del consumo, mentre potrebbero ancora mettere a disposizione energie e competenze per il bene comune.
Trova conferma, anche in questo caso, che un certo livellamento tra le generazioni è un problema, e che – al contrario – riannodare i fili del dialogo intergenerazionale è oggi più che mai necessario. L’io si sviluppa non nel chiuso della propria individualità, ma quando si apre all’altro differente da sé. E la famiglia è una preziosa custode delle differenze e della fecondità della loro relazione, della loro alleanza. Mentre oggi, con una efficace espressione della Ternynck, si permane negli ‘spazi incantati delle piccole differenze’ (che in realtà sono equivalenze, e che non vincolano), la famiglia resta lo spazio delle ‘grandi differenze’ che si completano nella reciprocità virtuosa: differenze di età e di sesso, di cultura e di storia. Per questo la famiglia è l’architrave portante di ogni realistico futuro![12].
Se pensiamo alla nostra famiglia, sentiamo – in un modo o nell’altro – un’onda di calore. Questo benefico calore cresce quanto più andiamo avanti negli anni, anche quando i nostri genitori sono già in cielo. Forse, anche nelle nostre famiglie ci sono state difficoltà e prove: non sempre tutto è ideale, né dei caratteri né degli affetti. Ciò nonostante, la famiglia ha tenuto duro, ha retto alle inevitabili usure e stanchezze, ad alti e bassi. E noi, figli di ieri e di oggi, abbiamo intuito che su quella realtà, su quel piccolo nucleo, potevamo contare. Sentivamo che, in mezzo alle durezze dell’esistenza, c’era una zona franca. Sentivamo che, dentro a quel grembo, i genitori avevano fiducia in noi nonostante i nostri limiti, errori, insuccessi o paure. Non era un nido dove fuggire dal mondo concreto, un mondo virtuale dove ci veniva risparmiata la parola severa, le regole. Al contrario! Era un luogo dove si faceva verità su di noi in modo saggio, dove si dava un nome giusto alle cose, dove si imparava la distinzione tra bene e male, tra doveri e diritti. Un luogo dove la presenza certa del papà e della mamma, e spesso anche dei fratelli, dei nonni e degli zii, ci dava coraggio e forza. E così, dentro a quel grembo accogliente ed esigente, abbiamo imparato ad avere fiducia in noi stessi, negli altri, nella vita. E la fiducia ha generato sicurezza. Abbiamo imparato a non aver paura delle prove, dei dolori, degli insuccessi; ad affrontarli con l’aiuto di Dio e degli altri. Quel luogo generatore – la famiglia – non era però un nucleo dai confini cangianti e dai tempi incerti, ma definito e permanente, su cui sapevamo di poter contare come su roccia ferma e affidabile. È questa la vera identità e la missione della famiglia che nel nostro Paese, nonostante tutto, rappresenta un punto di riferimento decisivo. Come sappiamo, esistono tendenze che mirano a cambiare il volto della famiglia, rendendola un soggetto plurimo e mobile, senza il sigillo oggettivo del matrimonio. Tra l’altro, rendendo sempre più brevi i tempi del divorzio, lo Stato non favorisce una ulteriore ponderazione su lacerazioni che lasceranno per sempre il segno, specie sui figli anche adulti. Ci chiediamo: i figli non hanno forse diritto a qualunque sacrificio pur di tenere salda e stabile la coppia e la famiglia? Indebolire la famiglia significa indebolire la persona e la società.
- 3. La logica dell’architettura familiare in relazione alla società
Una società che non investe sulla famiglia non investe sul suo futuro e si limita, come spesso dobbiamo costatare, ad affrontare emergenze e allocare risorse senza un chiaro progetto. La Dottrina sociale della Chiesa da sempre afferma che la famiglia va posta al centro delle politiche sociali, poiché rappresenta un perno per lo sviluppo, per il suo ruolo insostituibile nel generare e nel crescere la prole e per la partecipazione al mondo dell’economia e del lavoro: «Nulla è davvero garantito se a perdere è la famiglia; mentre ogni altra riforma, in modo diretto o indiretto, si avvantaggia se la famiglia prende quota»[13]. Con il matrimonio, infatti, nasce un nuovo soggetto, stabilmente costituito, con doveri e diritti che lo Stato riconosce e per i quali si impegna con normative specifiche. La ragione essenziale di tale coinvolgimento giuridico sta nel fatto che in ogni famiglia è in causa il bene comune sul duplice versante della continuità e della tenuta del tessuto sociale. La tenuta sociale, infatti, non dipende in primo luogo dalle leggi, ma dalla solidità della famiglia aperta alla trasmissione della vita e prima palestra di legami, luogo privilegiato dove si apprendono, si sperimentano e si rigenerano. Ogni individuo – in quanto soggetto di relazione – ha bisogno di vivere dentro ad una società solidale; ma perché questo accada, ha necessità di mondi prossimi, di nuclei vicini e stabili come solo la famiglia può assicurare. Senza questi mondi ravvicinati, la società vasta e complessa lo disorienta, gli crea smarrimento e insicurezza. Per queste ragioni lo Stato non è necessitato ad impegnarsi con ogni desiderio individuale o relazione, ma solo con quella realtà che ha rilevanza per il “corpo sociale” nel suo presente e nel suo futuro.
Si rende necessaria una convinta e attiva partecipazione all’azione politica perché trasmetta questa consapevolezza, capace di contrapporsi alla «disistima pratica che a livello pubblico è riservata all’istituto familiare»[14] e di sollecitare concreti interventi di sostegno. Ciò deve avvenire innanzitutto nell’ambito dell’educazione e della crescita dei figli – che sono un bene di tutta la società – nonché nel mondo del lavoro e sul piano delle agevolazioni fiscali.
È, infatti, indispensabile un fisco a misura di famiglia, basato sul quoziente familiare, che determini un circolo virtuoso tra le famiglie e la società nel suo insieme. Il lavoro deve essere organizzato in modo da rispettare le dinamiche relazionali tipiche della vita familiare, senza impedire i legittimi e necessari momenti di incontro e di riposo. Troppo spesso si esige da chi lavora che sia data totale priorità all’attività lavorativa, fino a trascurare le relazioni familiari. Va inoltre affrontato con efficacia il problema dell’occupazione, in particolare per non costringere i giovani a farsi emigranti impoverendo il Paese di giovinezza e di professionalità, o per non rischiare, come in parte sta già avvenendo, di lasciarli inoperosi, con conseguenze gravi sul versante sia personale che familiare e sociale.
La famiglia non deve essere solo oggetto delle politiche sociali, che purtroppo sono ancora insufficienti o inattuate. Essa deve farsi soggetto attivo, anche unendosi in associazioni, che con più forza portino il loro contributo e facciano sentire la loro voce. Il Forum delle Associazioni Familiari rappresenta in questo senso un esempio di come le famiglie siano più ascoltate quando portano avanti con determinazione e con un’unica voce, importanti istanze a promozione e difesa della persona e del nucleo familiare. La famiglia, come cellula sorgiva di relazioni, è il più efficace modello di comunità, dove si scopre che gli altri non sono soltanto un limite alla propria libertà, ma la condizione affinché si possa vivere liberi e felici.
La soggettività sociale della famiglia va promossa attraverso un’autentica sussidiarietà: le istituzioni devono dare spazio alla famiglia e alle associazioni familiari, che meglio conoscono i problemi e sanno valutare più correttamente, perché più da vicino, l’efficacia di certe proposte e soluzioni. Per questo l’esperienza e l’operatività della famiglia non vanno sprecate, ma incanalate a favore di tutto il corpo sociale. Ciò contribuisce a una maggiore personalizzazione della società, a una più consapevole assunzione di responsabilità delle famiglie stesse e a un alleggerimento del compito delle istituzioni pubbliche. La sussidiarietà, in questo senso, è una medicina salutare per tutta la società: ne facilita le dinamiche, si oppone al processo di burocratizzazione, canalizza l’esperienza e l’intraprendenza di ognuno per il bene comune. Tale sussidiarietà va applicata in primo luogo nei confronti delle famiglie, che devono sempre essere e sentirsi soggetti attivi e insostituibili.
La Chiesa, ben consapevole del ruolo fondamentale che la famiglia svolge nella società e nella Chiesa stessa, le si affianca nel suo cammino affascinante ma anche esigente. Per questo la Commissione Episcopale per la Famiglia ha pubblicato lo scorso anno gli Orientamenti sulla preparazione al matrimonio, che richiamano a tutta la comunità ecclesiale l’importanza di accompagnare i fidanzati nella loro preparazione alle nozze e nei primi anni della vita di famiglia. A loro si deve un’attenta cura, per aiutarli a scoprire il valore della loro scelta e ad assumersi con consapevolezza il vicendevole impegno per la vita. Purtroppo, alcuni fanno esperienza della lacerazione della vita matrimoniale: allora restano ferite gravi e dolori che lasciano il segno in tutti, in special modo nei figli. In questa significativa sede, rinnoviamo stima e vicinanza a quanti vivono in prima persona queste traumatiche lacerazioni e per le conseguenze che ne derivano. Ad essi vanno riservati una cordiale attenzione e un particolare accompagnamento, perché si sentano sempre parte attiva della comunità cristiana e ne sperimentino il sincero affetto.
La Chiesa propone instancabilmente la famiglia come la “prima dimora dell’umano” così come ricorda il Concilio Vaticano II: «il bene della persona e della società umana e cristiana è strettamente connesso con una felice situazione della comunità coniugale e familiare»[15]. Per questo il futuro ha bisogno della famiglia, perché il cammino della vita si apre solo quando si accoglie una relazione reale, cioè concreta e quotidiana. “Accogliendo la persona dell’altro, e specialmente quella dei figli, si accoglie l’avvenire. (…) A loro volta i figli partiranno. Affronteranno le bufere dell’esistenza, le sue tempeste probabilmente, ma lo faranno con tanta maggiore sicurezza se saranno cresciuti in una casa dalle mura e dal tetto solidi, dove avranno provato il gusto e il desiderio di edificare a loro volta”[16].
Io credo in Dio: il Padre onnipotente
Udienza Generale di Papa Benedetto XVI
Aula Paolo VI
Mercoledì, 30 gennaio 2013Cari fratelli e sorelle,
nella catechesi di mercoledì scorso ci siamo soffermati sulle parole iniziali del Credo: “Io credo in Dio”. Ma la professione di fede specifica questa affermazione: Dio è il Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Vorrei dunque riflettere ora con voi sulla prima, fondamentale definizione di Dio che il Credo ci presenta: Egli è Padre.
Non è sempre facile oggi parlare di paternità. Soprattutto nel mondo occidentale, le famiglie disgregate, gli impegni di lavoro sempre più assorbenti, le preoccupazioni e spesso la fatica di far quadrare i bilanci familiari, l’invasione distraente dei mass media all’interno del vivere quotidiano sono alcuni tra i molti fattori che possono impedire un sereno e costruttivo rapporto tra padri e figli. La comunicazione si fa a volte difficile, la fiducia viene meno e il rapporto con la figura paterna può diventare problematico; e problematico diventa così anche immaginare Dio come un padre, non avendo modelli adeguati di riferimento. Per chi ha fatto esperienza di un padre troppo autoritario ed inflessibile, o indifferente e poco affettuoso, o addirittura assente, non è facile pensare con serenità a Dio come Padre e abbandonarsi a Lui con fiducia.
Ma la rivelazione biblica aiuta a superare queste difficoltà parlandoci di un Dio che ci mostra che cosa significhi veramente essere “padre”; ed è soprattutto il Vangelo che ci rivela questo volto di Dio come Padre che ama fino al dono del proprio Figlio per la salvezza dell’umanità. Il riferimento alla figura paterna aiuta dunque a comprendere qualcosa dell’amore di Dio che però rimane infinitamente più grande, più fedele, più totale di quello di qualsiasi uomo. «Chi di voi, – dice Gesù per mostrare ai discepoli il volto del Padre – al figlio che gli chiede un pane, darà una pietra? E se gli chiede un pesce, gli darà una serpe? Se voi, dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono» (Mt 7,9-11; cfr Lc 11,11-13). Dio ci è Padre perché ci ha benedetti e scelti prima della creazione del mondo (cfr Ef 1,3-6), ci ha resi realmente suoi figli in Gesù (cfr 1Gv 3,1). E, come Padre, Dio accompagna con amore la nostra esistenza, donandoci la sua Parola, il suo insegnamento, la sua grazia, il suo Spirito.
Egli – come rivela Gesù – è il Padre che nutre gli uccelli del cielo senza che essi debbano seminare e mietere, e riveste di colori meravigliosi i fiori dei campi, con vesti più belle di quelle del re Salomone (cfr Mt 6,26-32; Lc 12,24-28); e noi – aggiunge Gesù – valiamo ben più dei fiori e degli uccelli del cielo! E se Egli è così buono da far «sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e … piovere sui giusti e sugli ingiusti» (Mt 5,45), potremo sempre, senza paura e con totale fiducia, affidarci al suo perdono di Padre quando sbagliamo strada. Dio è un Padre buono che accoglie e abbraccia il figlio perduto e pentito (cfr Lc 15,11ss), dona gratuitamente a coloro che chiedono (cfr Mt 18,19; Mc 11,24; Gv 16,23) e offre il pane del cielo e l’acqua viva che fa vivere in eterno (cfr Gv 6,32.51.58).
Perciò l’orante del Salmo 27, circondato dai nemici, assediato da malvagi e calunniatori, mentre cerca aiuto dal Signore e lo invoca, può dare la sua testimonianza piena di fede affermando: «Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto» (v. 10). Dio è un Padre che non abbandona mai i suoi figli, un Padre amorevole che sorregge, aiuta, accoglie, perdona, salva, con una fedeltà che sorpassa immensamente quella degli uomini, per aprirsi a dimensioni di eternità. «Perché il suo amore è per sempre», come continua a ripetere in modo litanico, ad ogni versetto, il Salmo 136 ripercorrendo la storia della salvezza. L’amore di Dio Padre non viene mai meno, non si stanca di noi; è amore che dona fino all’estremo, fino a sacrificio del Figlio. La fede ci dona questa certezza, che diventa una roccia sicura nella costruzione della nostra vita: noi possiamo affrontare tutti i momenti di difficoltà e di pericolo, l’esperienza del buio della crisi e del tempo del dolore, sorretti dalla fiducia che Dio non ci lascia soli ed è sempre vicino, per salvarci e portarci alla vita eterna.
È nel Signore Gesù che si mostra in pienezza il volto benevolo del Padre che è nei cieli. È conoscendo Lui che possiamo conoscere anche il Padre (cfr Gv 8,19; 14,7), è vedendo Lui che possiamo vedere il Padre, perché Egli è nel Padre e il Padre è in Lui (cfr Gv 14,9.11). Egli è «immagine del Dio invisibile» come lo definisce l’inno della Lettera ai Colossesi, «primogenito di tutta la creazione… primogenito di quelli che risorgono dai morti», «per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati» e la riconciliazione di tutte le cose, «avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli» (cfr Col 1,13-20).
La fede in Dio Padre chiede di credere nel Figlio, sotto l’azione dello Spirito, riconoscendo nella Croce che salva lo svelarsi definitivo dell’amore divino. Dio ci è Padre dandoci il suo Figlio; Dio ci è Padre perdonando il nostro peccato e portandoci alla gioia della vita risorta; Dio ci è Padre donandoci lo Spirito che ci rende figli e ci permette di chiamarlo, in verità, «Abbà, Padre» (cfr Rm 8,15). Perciò Gesù, insegnandoci a pregare, ci invita a dire “Padre nostro” (Mt 6,9-13; cfr Lc 11,2-4).
La paternità di Dio, allora, è amore infinito, tenerezza che si china su di noi, figli deboli, bisognosi di tutto. Il Salmo 103, il grande canto della misericordia divina, proclama: «Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso coloro che lo temono, perché egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere» (vv. 13-14). E’ proprio la nostra piccolezza, la nostra debole natura umana, la nostra fragilità che diventa appello alla misericordia del Signore perché manifesti la sua grandezza e tenerezza di Padre aiutandoci, perdonandoci e salvandoci.
E Dio risponde al nostro appello, inviando il suo Figlio, che muore e risorge per noi; entra nella nostra fragilità e opera ciò che da solo l’uomo non avrebbe mai potuto operare: prende su di Sé il peccato del mondo, come agnello innocente, e ci riapre la strada verso la comunione con Dio, ci rende veri figli di Dio. È lì, nel Mistero pasquale, che si rivela in tutta la sua luminosità il volto definitivo del Padre. Ed è lì, sulla Croce gloriosa, che avviene la manifestazione piena della grandezza di Dio come “Padre onnipotente”.
Ma potremmo chiederci: come è possibile pensare a un Dio onnipotente guardando alla Croce di Cristo? A questo potere del male, che arriva fino al punto di uccidere il Figlio di Dio? Noi vorremmo certamente un’onnipotenza divina secondo i nostri schemi mentali e i nostri desideri: un Dio “onnipotente” che risolva i problemi, che intervenga per evitarci le difficoltà, che vinca le potenze avverse, cambi il corso degli eventi e annulli il dolore. Così, oggi diversi teologi dicono che Dio non può essere onnipotente altrimenti non potrebbe esserci così tanta sofferenza, tanto male nel mondo. In realtà, davanti al male e alla sofferenza, per molti, per noi, diventa problematico, difficile, credere in un Dio Padre e crederlo onnipotente; alcuni cercano rifugio in idoli, cedendo alla tentazione di trovare risposta in una presunta onnipotenza “magica” e nelle sue illusorie promesse.
Ma la fede in Dio onnipotente ci spinge a percorrere sentieri ben differenti: imparare a conoscere che il pensiero di Dio è diverso dal nostro, che le vie di Dio sono diverse dalle nostre (cfr Is 55,8) e anche la sua onnipotenza è diversa: non si esprime come forza automatica o arbitraria, ma è segnata da una libertà amorosa e paterna. In realtà, Dio, creando creature libere, dando libertà, ha rinunciato a una parte del suo potere, lasciando il potere della nostra libertà. Così Egli ama e rispetta la risposta libera di amore alla sua chiamata. Come Padre, Dio desidera che noi diventiamo suoi figli e viviamo come tali nel suo Figlio, in comunione, in piena familiarità con Lui. La sua onnipotenza non si esprime nella violenza, non si esprime nella distruzione di ogni potere avverso come noi desideriamo, ma si esprime nell’amore, nella misericordia, nel perdono, nell’accettare la nostra libertà e nell’instancabile appello alla conversione del cuore, in un atteggiamento solo apparentemente debole – Dio sembra debole, se pensiamo a Gesù Cristo che prega, che si fa uccidere. Un atteggiamento apparentemente debole, fatto di pazienza, di mitezza e di amore, dimostra che questo è il vero modo di essere potente! Questa è la potenza di Dio! E questa potenza vincerà! Il saggio del Libro della Sapienza così si rivolge a Dio: «Hai compassione di tutti, perché tutto puoi; chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, aspettando il loro pentimento. Tu infatti ami tutte le cose che esistono… Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore, amante della vita» (11,23-24a.26).
Solo chi è davvero potente può sopportare il male e mostrarsi compassionevole; solo chi è davvero potente può esercitare pienamente la forza dell’amore. E Dio, a cui appartengono tutte le cose perché tutto è stato fatto da Lui, rivela la sua forza amando tutto e tutti, in una paziente attesa della conversione di noi uomini, che desidera avere come figli. Dio aspetta la nostra conversione. L’amore onnipotente di Dio non conosce limiti, tanto che «non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi» (Rm 8,32). L’onnipotenza dell’amore non è quella del potere del mondo, ma è quella del dono totale, e Gesù, il Figlio di Dio, rivela al mondo la vera onnipotenza del Padre dando la vita per noi peccatori. Ecco la vera, autentica e perfetta potenza divina: rispondere al male non con il male ma con il bene, agli insulti con il perdono, all’odio omicida con l’amore che fa vivere. Allora il male è davvero vinto, perché lavato dall’amore di Dio; allora la morte è definitivamente sconfitta perché trasformata in dono della vita. Dio Padre risuscita il Figlio: la morte, la grande nemica (cfr 1 Cor 15,26), è inghiottita e privata del suo veleno (cfr 1 Cor 15,54-55), e noi, liberati dal peccato, possiamo accedere alla nostra realtà di figli di Dio.
Quindi, quando diciamo “Io credo in Dio Padre onnipotente”, noi esprimiamo la nostra fede nella potenza dell’amore di Dio che nel suo Figlio morto e risorto sconfigge l’odio, il male, il peccato e ci apre alla vita eterna, quella dei figli che desiderano essere per sempre nella “Casa del Padre”. Dire «Io credo in Dio Padre onnipotente», nella sua potenza, nel suo modo di essere Padre, è sempre un atto di fede, di conversione, di trasformazione del nostro pensiero, di tutto il nostro affetto, di tutto il nostro modo di vivere.
Cari fratelli e sorelle, chiediamo al Signore di sostenere la nostra fede, di aiutarci a trovare veramente la fede e di darci la forza di annunciare Cristo crocifisso e risorto e di testimoniarlo nell’amore a Dio e al prossimo. E Dio ci conceda di accogliere il dono della nostra filiazione, per vivere in pienezza le realtà del Credo, nell’abbandono fiducioso all’amore del Padre e alla sua misericordiosa onnipotenza che è la vera onnipotenza e salva.
Ne’ comunione ne’ scomunica
Intervista a S.E. Mons. Luigi Negri (Il Timone, Maggio 2010, pp. 42-43)
Monsignor Luigi Negri spiega: il primo dovere della Chiesa è difendere i diritti di Dio, mentre non esiste per nessuno un “diritto ai sacramenti”. I divorziati risposati esclusi dalla vita cristiana? È una menzogna frutto della mentalità laicista e terroristica
di Roberto Beretta
I giornali lo cercano spesso perché, in genere, le sue parole sono piuttosto lontane dalle maniere moderate e clericali tipiche di tanti altri suoi colleghi e – dunque – «fanno notizia». In effetti a volte le dichiarazioni di monsignor Luigi Negri – teologo e vescovo di San Marino Montefeltro – risultano spigolose, persino rudi; ma di sicuro hanno il pregio di una chiarezza quasi didascalica. E riservano quasi sempre qualche sorpresa anche agli habitués.
Monsignor Negri, cominciamo subito dall’obiezione più comune, fors’anche qualunquista ma con una certa presa pure tra i cattolici: perché tanta intransigenza della Chiesa verso i divorziati non sposati, tanto da essere ritenuta più severa nei loro riguardi che verso altre categorie di peccatori, per esempio i ladri o i disonesti?
«Dato e non concesso che sia vera la seconda parte della domanda, e cioè che la Chiesa non usi una bilancia corretta per la gravità dei peccati, non si tratta tanto di intransigenza verso i divorziati, quanto di un dovere nei confronti di Dio. La prima difesa che la Chiesa deve mettere in pratica è infatti quella dei diritti di Dio. La fedeltà e l’unità degli sposi si radicano nella fedeltà di Dio, il matrimonio è un sacramento di Cristo e la Chiesa deve rispettare quanto le è affidato non perché venga manipolato, ma perché si resti il più possibile fedeli al messaggio originario. Bisogna poi dire una cosa molto chiara: sostenere che i divorziati risposati sono esclusi dalla vita cristiana è sbagliato, è il frutto di una mentalità laicista e terroristica; ogni fedele vive nella Chiesa secondo la sua capacità e non è detto che la partecipazione alla vita ecclesiale si debba livellare sulla pratica dell’eucaristia: c’è tutta una gradualità di posizioni, che rispondono a casi in cui ci si può trovare anche per propria volontà. Non possiamo dunque ragionare solo nell’ottica delle condizioni individuali, in quanto c’è pure un coinvolgimento della libertà personale nella scelta di mettersi in una certa situazione; e ognuno deve assumersi le responsabilità delle decisioni che prende. Verso i divorziati che non passano a nuove nozze, difatti, la Chiesa si è ben guardata dal praticare una cosiddetta intransigenza».
Altra accusa ricorrente: il processo di annullamento dei matrimoni cattolici costa molto, è lungo, ottiene esito positivo solo per chi ha conoscenze altolocate e in fondo è solo un “trucchetto” per concedere il divorzio ai soliti privilegiati … Come smentire?
«Queste affermazioni fanno parte di una classica “leggenda nera” che va decisamente smontata. La Chiesa è estremamente garantista, conduce processi in cui tutti i fattori vengono tenuti presenti, senza pregiudizio verso nessuna parte. La questione economica poi non si pone proprio: addirittura, a volte è la diocesi che offre il patrocinio d’ufficio e si può fare tutto senza spendere praticamente niente. Il problema è semmai un altro: anche a detta dei due ultimi Papi, nei loro discorsi ai tribunali ecclesiastici, si verifica una certa disinvoltura nella concessione delle nullità matrimoniali.
Credo in effetti che ci sia il pericolo che la Chiesa ceda qualche volta con una certa facilità a pressioni massmediatiche o alla mentalità comune. Ma questo va esattamente in senso opposto all’obiezione da cui siamo partiti».
A proposito del divieto di comunicarsi per i divorziati risposati, lei ha scritto: «I sacramenti non sono un diritto acquisito. Nella mentalità di tanti cristiani, a volte, si insinua invece un’idea di rivendicazione sindacale».
Certo, si può vivere ed essere cristiani anche senza avere l’eucaristia; però è bello che si aspiri al massimo della comunione, no?
«È vero che l’eucaristia è il culmine della vita cristiana. Ma, se mi sono messo consapevolmente e liberamente nelle condizioni di non arrivare su tale vetta, non posso pretendere di farlo a tutti i costi… Nessuno ha diritto a nessun sacramento, tutti sono frutto della grazia di Cristo. E la privazione della pratica sacramentale non è come ad esempio la scomunica latae sententiae per chi fa l’aborto: non esclude la possibilità di fare un’esperienza di Chiesa, pur senza giungere al vertice. D’altra parte nessuno ha costretto questi fratelli a divorziare, tanto meno la Chiesa. E arrivare al punto massimo della liturgia non è un assoluto. Bisogna saper tradurre questo desiderio in preghiera e in sacrificio: la comunione di desiderio, come si diceva una volta».
Dunque per i divorziati risposati non c’è, diciamo così, alcuna scorciatoia.
«Devono rimuovere la condizione di irregolarità in cui si sono messi: la nuova situazione affettiva, la cosiddetta nuova famiglia, il matrimonio civile che rende impossibile la partecipazione piena alla vita alla Chiesa; ma non da oggi: da sempre! E dunque la verità è che, in ogni caso, si deve mettere in conto un sacrificio. Per il resto, ribadisco che nella vita della Chiesa esiste una bellissima articolazione di carismi e di possibilità: chi impedisce, per esempio, ai divorziati risposati di vivere in ogni caso un’intensa vita di carità o di preghiera?».
“Il disegno di Dio per l’uomo e la donna nel sacramento del matrimonio. Il mistero nuziale e la cultura contemporanea”.
Estratto dell’intervento del Patriarca Angelo Scola al Congresso delle Famiglie cattoliche promosso dalla Conferenza Episcopale della Scandinavia, 14 – 16 maggio a Jönköping (Svezia)
La mia presenza tra voi ha per me due ragioni.
La prima è legata alla bellezza e alla necessità che lo scambio di comunione tra le Chiese sia perseguito con sempre maggior tenacia. La comunione tra i battezzati documenta visibilmente quell’unità necessaria a che «il mondo creda» (Gv 17,21).
La seconda è una convinzione recentemente ribadita da Benedetto XVI in occasione della Visita ad limina Apostolorum dei Vescovi dei Paesi Scandinavi proprio con riferimento al presente Convegno. Il Papa ha parlato della «centralità della famiglia per la vita di una società sana» che implica un approfondimento ed impegno per «l’istituto del matrimonio e dell’idea cristiana di sessualità umana»1. L’uomo di oggi – il cosiddetto uomo post-moderno – è, nello stesso tempo, confuso ed assetato. Per questo ha bisogno di incontrare uomini e donne capaci di testimoniare l’entusiasmo che sgorga dalla singolare bellezza del sacramento del matrimonio.
….
1. Amore, matrimonio e famiglia alla prova
Per cominciare è opportuno partire dalla realtà che le società dell’area euroatlantica ci presentano. Il clima culturale attuale viene ormai sinteticamente evocato dalla categoria di post-moderno. Ovviamente questo concetto comprende una varietà di significati e non ci è possibile riassumerli tutti qui. Mi sembra tuttavia che alcune sue caratteristiche siano abbastanza facilmente osservabili.
Anzitutto si impone una situazione di secolarizzazione avanzata. Ovviamente la secolarizzazione non è la stessa in tutti i paesi. Non si possono quindi stabilire immediati parallelismi tra i vostri paesi e, per esempio, l’Italia. O tra l’Italia e la Francia e la Germania. Mi pare tuttavia che un nucleo comune alla secolarizzazione di tutte le società euro-atlantiche risieda in quella che il filosofo canadese Taylor ha definito la secolarizzazione 3. Essa consiste nel considerare le fede in Dio come un’opzione tra le altre. Si è passati cioè da società in cui era «virtualmente impossibile non credere in Dio, ad una in cui anche per il credente più devoto questa è solo una possibilità umana tra le altre»2.
Il secondo tratto della post-modernità, non staccato dal precedente, è che l’uomo odierno rischia di enfatizzare a tal punto la libertà di scelta individuale da considerarla tutta la libertà. Essa risulta in tal modo svincolata da qualsiasi bene oggettivo.
Il terzo dato è lo straordinario connubio che si è realizzato negli ultimi due secoli tra la scienza e la tecnica, in modo particolare nell’ambito della biologia e oggi sempre più in quello delle neuroscienze. Esso ha comportato un profondo cambiamento nella visione della realtà. Il vero non è più dato dalla corrispondenza tra l’intelletto e la “cosa” (adaequatio rei et intellectus), al limite neppure da ciò che è empiricamente osservabile. Il vero è ridotto a ciò che è tecnicamente fattibile. Ciò finisce per stabilire una pericolosa equazione: “si può, quindi si deve”3 (imperativo tecnologico).
L’intreccio di questi fattori ha inoltre radicalmente modificato il modo con cui l’uomo concepisce se stesso, dando origine a trasformazioni e a situazioni inedite anche nell’ambito dell’amore e della famiglia. Il divorzio, le coppie di fatto, le unioni dello stesso sesso, la realtà dei singles, la contraccezione, l’aborto, la procreazione medicalmente assistita, la possibilità di effettuare diagnosi prenatali o pre-impianto, la clonazione, l’omosessualità, hanno prodotto nella sfera dell’amore, del matrimonio e della famiglia una serie di separazioni: tra la coppia e l’essere genitori, tra l’essere genitori e il procreare, tra la coppia-famiglia e la differenza sessuale4. Queste mutazioni non si arrestano alla sfera privata, ma investono la stessa vita civile. Il legislatore infatti, anche qui in grado diverso secondo i diversi paesi dell’area euro-atlantica, appare sempre più disponibile a garantire norma di legge ad ogni “desiderio” del soggetto, per giunta ampliato dalle indefinite possibilità offerte dalla tecno-scienza.
Da un simile contesto scaturiscono per noi una serie di domande: la differenza sessuale, l’amore e la fecondità devono essere considerati fatti contingenti oggi superabili – e forse già superati – o possiedono un valore assoluto? Questi tre fattori, presi in unità, sono realmente essenziali per l’esperienza del matrimonio e della famiglia? La loro unità merita di essere mantenuta e consapevolmente perseguita come qualcosa che chiede alla libertà di ogni persona di scegliere ciò che è buono in vista del suo proprio bene? La famiglia fondata sull’unione matrimoniale fedele, pubblica e aperta alla vita di un uomo e di una donna è veramente la strada adeguata allo sviluppo integrale della persona? Venendo ai vostri paesi e considerando la pluralità di mondovisioni di cui sono portatori i soggetti che li abitano, a partire dalla differenza tra credenti e non credenti, passando per le diverse appartenenze ecclesiali e religiose che danno origine ad un numero elevato di matrimoni misti ed interreligiosi, come far convivere positivamente tale pluralità all’interno della famiglia stessa?
Tutte queste brucianti questioni non fanno che proporre con urgenza un’ulteriore domanda, che sintetizza tutte le precedenti, e a cui ognuno di noi è oggi chiamato, almeno implicitamente a rispondere: chi vuol essere l’uomo del terzo millennio? Infatti, se fino alla caduta dei muri abbiamo assistito a una contesa sull’essere umano (Giovanni Paolo II) in cui però l’oggetto del contendere – l’uomo, appunto – restava, in qualche modo, identificabile, oggi ci troviamo invece di fronte ad un forte smarrimento nel cogliere chi sia l’uomo in se stesso.
Due sono le strade su cui l’uomo post-moderno cerca una risposta.
Per la prima egli vuole essere «soltanto il suo proprio esperimento», secondo un’espressione usata da un filosofo tedesco della scienza. Basta con i discorsi sulla persona e sulla sua dignità intesi come principi universali ed assoluti!
La seconda strada invece conduce a pensare in modo rinnovato questi fondamenti a partire dalla natura relazionale (comunionale) della persona.
Va inoltre sottolineato il fatto che se l’uomo di oggi si trova a questo bivio, allora, come il nostro incontro conferma, la Chiesa è chiamata ad una nuova evangelizzazione. Essa deve lasciar trasparire sul suo volto Gesù Cristo, Lumen gentium. Per sua natura deve mostrare come l’evento di Gesù Cristo sia contemporaneo all’uomo di ogni tempo nella sua unità di anima e corpo (corpore et anima unus, GS 14). Allora tutti gli aspetti umani connessi con l’esperienza nuziale quali l’affettività, l’amore, il matrimonio, la famiglia, la maternità, la paternità, la fraternità, l’amicizia, ma anche il celibato e la verginità consacrata, rappresentano un canale attraverso il quale la Chiesa, Madre e Maestra si prende cura, nell’attuale frangente storico, degli uomini, delle comunità e dei popoli.
…
2. Il mistero nuziale: differenza sessuale, dono di sé, fecondità
Il modo più adeguato per trattare le problematiche fin qui descritte è quello di leggerle attraverso la lente del mistero nuziale nelle sue tre indisgiungibili dimensioni: differenza sessuale, dono di sé, fecondità. L’espressione mistero nuziale infatti svela il carattere profondo dell’amore perché, nel manifestare la sua capacità di mettere in campo l’io, l’altro e l’unità dei due, conduce al cuore dell’esperienza umana elementare5, cioè comune ad ogni persona di ogni tempo e luogo. Il fatto che sia un mistero non si riferisce ad una sua assoluta inconoscibilità. Suggerisce soltanto che essendo una delle dimensioni con cui la libertà personale di ogni uomo entra in relazione con l’infinito, non può essere catturata una volta per tutte in una definizione. A questo proposito scrive Evdokimov: «Nessuno tra i poeti ed i pensatori ha trovato la risposta della domanda: “Che cosa è l’amore?” […] Volete imprigionare la luce? Vi sfuggirà di tra le dita»6.
Esaminiamo quindi brevemente i tre aspetti costitutivi del mistero nuziale senza tuttavia mai dimenticare che essi non possono mai essere separati. Ognuno mette sempre in campo anche gli altri due.
a) Differenza sessuale
Il tema della differenza sessuale, prima dimensione del mistero nuziale, è stato sviluppato dal Magistero di Giovanni Paolo II per approfondire la forza profetica di Humanae vitae a partire dalle sue Catechesi sull’amore umano7 e ripreso recentemente da Benedetto XVI nella Deus caritas est8.
…
Il rapporto tra maschile e femminile chiede quindi di essere pensato simultaneamente attraverso le categorie dell’identità e della differenza. Mentre la prima è abbastanza facilmente riconducibile alla natura personale dell’essere umano e alla conseguente uguale dignità tra l’uomo e la donna (entrambi parimenti esseri umani), la seconda non è priva di problematicità, come attesta il travaglio della cultura contemporanea nella sua radicale difficoltà a pensare la differenza sessuale.
….
La differenza sessuale, integralmente intesa, si rivela come la modalità primaria con cui il singolo, uno di anima e corpo, entra in contatto con il reale. La consapevolezza del proprio essere sempre situato nella differenza sessuale realizza una costante apertura all’altro e indica un cammino di conoscenza di sé. Da qui si capisce che la differenza9 (dif-ferre: portare altrove lo stesso) non può mai essere abolita. È infatti una insuperabile dimensione dell’io personale.
b) Apertura all’altro come dono di sé
È proprio nella differenza sessuale adeguatamente vissuta che l’apertura all’altro può prendere la forma del dono di sé. Muovendo da questo dato si comprende meglio il nesso tra mistero nuziale e sacramento del matrimonio, la cui giustificazione ultima prende le mosse dal linguaggio nuziale della Bibbia10. La tradizione teologica ci propone una via di riflessione nella cornice del testo di Efesini 5,21-33. In questo testo l’esperienza umana dell’amore fra gli sposi, basata sulla differenza sessuale, viene illuminata dall’analogia con l’amore sponsale di Gesù Cristo per la Chiesa, del quale proprio in virtù del sacramento del matrimonio partecipano gli sposi cristiani. Sia chiaro: il sacramento non è un’aggiunta al dato naturale, ma è ciò che lo spiega in profondità. Di qui l’invito di San Paolo agli sposi perché sappiano partecipare di un amore che deve essere totale, personale, redentore e fecondo. Ed è un dato che vale anche per gli sposi battezzati appartenenti a tradizioni cristiane diverse, dal momento che, «in forza del loro battesimo, sono realmente già inseriti nell’Alleanza sponsale di Cristo, con la Chiesa e, per la loro retta intenzione, hanno accolto il progetto di Dio sul matrimonio»11.
Radicata nella differenza sessuale, per essere all’altezza della sua vocazione l’unione tra l’uomo e la donna deve essere fedele e aperta alla vita. Ce lo indica il Catechismo della Chiesa cattolica quando parla dei beni-esigenze del matrimonio12. In proposito è di decisiva importanza superare un grave equivoco. Queste non sono proprietà che si aggiungono all’amore tra l’uomo e la donna. Esse fanno parte dell’essenza dell’amore. Là dove non c’è fedeltà e fecondità non c’è mai stato propriamente parlando amore13. Non si tratta di precetti aggiunti dalla Chiesa quasi per frenare la libera espressione dell’amore. Sono i beni che emergono dalla natura profonda dell’amore umano. In quanto essenziali all’amore essi, benché messi radicalmente in discussione da buona parte dei costumi e della cultura contemporanei, sono sempre in grado di mostrare la loro attualità.
Vediamo brevemente in che modo.
In uno dei suoi ultimi libri, il grande filosofo cattolico Jean Guitton con molta autoironia descrive la sua morte, i suoi funerali e il giudizio di Dio sulla sua vita. Immagina che la sua anima, separata dal corpo, dialoghi con filosofi, poeti, papi, politici. Nel dialogo che riguarda l’amore, in cui Guitton conversa con sua moglie e il poeta Dante, troviamo questa geniale affermazione: «Alcuni si sposano perché si amano, altri finiscono per amarsi perché sono sposati. È meglio che in ogni matrimonio ci siano l’uno e l’altro. “Perché si finisce per amarsi, una volta sposati? È forse il bisogno di conservare la piega che abbiamo preso?”» chiede Guitton. Sua moglie risponde: «“Ci deve essere dell’altro, se si tratta di amore”. “Marie-Louise, qual è quest’altra cosa?”. “Deve riguardare il tempo e l’eternità”»14. Non esiste amore che non implichi il desiderio del “per sempre”. Ce lo dice il fenomeno dell’innamoramento, quando è ascoltato in tutta la sua serietà. Fa parte dell’esperienza di chi ama voler consegnare tutto se stesso senza limiti temporali. Ed è proprio dell’esperienza di chi è amato desiderare che l’amore che lo abbraccia non abbia mai fine. Nel mio compito pastorale mi rivolgo sempre ai giovani in questo modo: “Vi sfido se siete autenticamente innamorati, a dire “ti amo” senza aggiungere “per sempre”. Il “per sempre” fa parte essenzialmente dell’amore. Il genio di Shakespeare lo ha messo in evidenza nel versetto fulminante di un sonetto: «Amore non è amore / se muta quando nell’altro scorge mutamenti / o se tende a recedere quando l’altro si allontana»15.
Se questo è vero per ogni esperienza di sincero innamoramento, tanto più il per sempre dovrà essere presente nell’amore dei coniugi e dei coniugi cristiani.
…
Da quanto detto si capisce meglio cosa intende la Chiesa quando ripropone l’ingiunzione del Signore «quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi» (Mt 19,6). Il versetto ricorda che la decisione umana per l’amore realizza la volontà di continuare l’opera di Dio che ci ha creati maschio e femmina. Al contrario di quanto parte della cultura contemporanea sembra suggerire, l’unione per sempre non è un peso inflitto alla nostra libertà, ma una condizione per poterla mettere in atto. L’indissolubilità rappresenta infatti la possibilità che la libertà si compia, che il desiderio di essere amato e di amare trovi soddisfazione fino a rendere trasparente il disegno originario del Padre sul matrimonio. Tutto questo non è il risultato di una capacità etica superiore degli sposi. Tale pienezza è possibile solo se marito e moglie vivono quotidianamente il proprio rapporto come sacramento, come forma concreta del loro essere Chiesa domestica. A questo livello si capisce quanto sia importante nella vita dei coniugi un’intensa vita sacramentale e una continua ripresa della consapevolezza del proprio battesimo e della propria appartenenza a Cristo. E intorno a questo centro, è offerta la grande possibilità della dedizione vicendevole mediante l’esperienza del perdono16.
c) Fecondità
Per scoprire dove conduce l’amore preso nella sua integralità occorre tornare alla sua origine. Per capire cioè il terzo fattore del mistero nuziale, la fecondità – che è l’esito a cui tende il dono di sé – dobbiamo ripartire dal primo fattore: la differenza sessuale. Ricordiamo che questa dice che l’io è strutturalmente riferito al tu. L’apertura all’altro è costitutiva dell’identità della persona. Lo sposo e la sposa che, in virtù della differenza sessuale, si donano reciprocamente, diventano una carne sola e si spalancano alla procreazione del figlio. Proprio perché fin dentro l’unione coniugale i due non si fondono in un’unità che ingloba entrambi, ma esprimono una piena comunione pur restando persone differenti, essi fanno posto al terzo. A questo proposito il grande teologo svizzero Hans Urs von Balthasar ha potuto genialmente affermare che «l’atto dell’unione di due persone nell’unica carne e il frutto di questa unione dovrebbero essere considerati insieme saltando la distanza nel tempo»17. Questa affermazione rende ragione della forza profetica di Humanae vitae. La procreazione del figlio, che implica l’affascinante avventura educativa, esprime il significato pieno del matrimonio18.
Mi preme aggiungere, per inciso, che anche nei matrimoni misti e in quelli interreligiosi se gli sposi sono resi consapevoli delle difficoltà e rispettano fino in fondo quanto stabilito a livello canonico è possibile una profonda esperienza dell’amore coniugale.
“Educare: una responsabilità, un compito, una gioia”
Relazione del Card. Carlo Caffarra al convegno organizzato dalla FISM
Teatro dell’Osservanza – Imola, 3 maggio 2010
Il Vs. Ecc.mo Vescovo mi ha chiesto di sottoporre alla vostra riflessione alcune considerazioni che prendono spunto dalla Carta formativa della Scuola cattolica dell’Infanzia, un documento che ho pubblicato nel settembre scorso.
1. Essenzialmente il rapporto educativo è un rapporto fra un’autorità ed una libertà.
Il contenuto di questo rapporto è costituito dall’offerta di una proposta di vita fatta dalla persona autorevole alla persona in formazione.
Che cosa si intende per “proposta di vita”? Se paragoniamo la vita alla costruzione di un edificio, ciò che è il progetto per l’edificio è la “proposta di vita” [che costituisce il contenuto del rapporto educativo] per la persona educanda.
In queste semplici osservazioni è racchiuso tutto: il compito, la responsabilità, la gioia di educare. Ma anche i gravi problemi.
2. Esistono alcuni presupposti che implicitamente o esplicitamente devono essere ammessi dall’educatore, altrimenti la relazione educativa non può neppure essere istituita, o rischia comunque di isterilirsi.
→ La libertà ed il suo esercizio non è un assoluto al di sopra del quale e prima del quale non esiste nulla. Mi spiego con un esempio molto semplice. Hitler e Madre Teresa hanno vissuto secondo un progetto esistenziale liberamente scelto e realizzato. Sono sicuro che nessuno di voi però pensa che sia la vita di Hitler che la vita di Madre Teresa meritano lo stesso giudizio, dal momento che ambedue erano liberamente vissute.
L’esempio ci fa capire una cosa di fondamentale importanza. Esistono progetti di vita buoni e progetti di vita cattivi. O – il che equivale – esiste una verità circa ciò che è bene e ciò che è male, che precede l’esercizio della nostra libertà e in base alla quale esso è giudicato.
Perché una persona si assume il compito e la responsabilità di fare ad un’altra una precisa proposta di vita? Perché ritiene che questa proposta sia vera: dica cioè la verità circa ciò che è il bene e il male della persona. Ed anche perché ritiene che l’altro possa sbagliarsi nel progettare la sua vita: siamo al secondo presupposto.
→ La persona umana nasce avendo nel cuore un desiderio illimitato di beatitudine, e in questo desiderio di beatitudine la mano creatrice di Dio ha seminato una inestinguibile sete di verità e di bontà. La persona umana, quando giunge nel mondo, è come una grande promessa che può essere realizzata e può essere delusa. Non può essere lasciata a se stessa: ha bisogno di essere, e chiede di essere aiutata a realizzarsi nella verità e nel bene. L’atto educativo nasce dalla condivisione del destino dell’altro. Non una condivisione qualsiasi, ma che si concretizza precisamente nell’indicazione della via che porta alla beatitudine.
→ Tutto questo comporta da parte dell’educatore una visione della persona umana; l’educatore deve saper rispondere alla domanda: chi è l’uomo? Il rapporto educativo si radica sempre in un’antropologia.
3. A questo punto abbiamo tutti gli elementi per definire il rapporto educativo dal punto di vista della fede cristiana.
Esso si istituisce quando l’educatore fa alla persona educanda la proposta cristiana della vita. È fondamentale capire che cosa significa “proposta cristiana della vita”.
Gli storici dell’arte cristiana ci dicono che sui più antichi sarcofagi Cristo era spesso raffigurato sotto la figura del filosofo e del pastore. Tralasciamo la considerazione della seconda raffigurazione, e riflettiamo sulla prima.
Nell’antichità, filosofo era colui che insegnava “l’arte di essere uomo in modo retto – l’arte di vivere e morire”. Raffigurando Cristo come filosofo, i nostri fratelli di fede volevano dirci: “Egli ci dice chi in realtà è l’uomo e che cosa egli deve fare per essere veramente uomo. Egli ci indica la via e questa via è la verità” [Benedetto XVI, Lett. Enc. Spe salvi 6].
La proposta cristiana della vita è l’indicazione di come realizzare la nostra umanità secondo la via indicataci da Cristo e sempre presente nella Tradizione della Chiesa.
Due precisazioni importanti. La proposta cristiana non si aggiunge estrinsecamente alla realizzazione della nostra umanità, ma è la modalità della perfetta realizzazione della medesima. Quando poi si parla di “vita umana” si intende tutto ciò che concretamente costituisce la trama della nostra vita quotidiana. L’educazione dunque cristiana si definisce in riferimento alla proposta di vita propria della visione cristiana [cfr. art. 2 della Carta formativa].
Possono sorgere dentro di noi a questo punto due difficoltà nei confronti della definizione cristiana di educazione.
La prima: in un contesto sempre più pluralistico, anche dal punto di vista religioso, non è contrario ad una pacifica convivenza sociale educare la persona ad una forte identità? Questa difficoltà fa parte oggi del comune sentire, e sembra essere come una specie di dogma indiscutibile. In realtà è profondamente disumana e disumanizzante. Per varie ragioni. Ne accenno alcune.
Essa parte da una visione astratta della persona umana, cioè falsa. Ogni persona umana nasce all’interno di una cultura e di una tradizione. Realizza cioè la comune umanità nella molteplice diversità delle culture. La convivenza fra varie persone non si ottiene azzerando le diversità, credendo in questo modo di raggiungere la natura umana “pulita” da ogni incrostazione storica. Sarebbe come se, partendo dal fatto che di ogni uomo è proprio il linguaggio, si ritenesse che esista una sola lingua uguale per tutti.
Poiché è questa una visione astratta, non reale, ideologica, c’è un solo modo per proporla: imporla per legge. [cfr. il tentativo di una Costituzione Europea]. Pensare di creare comunione interpersonale, vera convivenza mediante le regole, è un’illusione. Se non altro perché non esiste regola capace di far rispettare le regole.
La seconda difficoltà: educare nel modo suddetto non è contro la libertà della persona? Anche questa idea che vede l’educazione e la libertà come due grandezze confliggenti è oggi comune, ma va rifiutata.
La libertà umana non è della stessa natura della spontaneità animale. La libertà umana è un auto-determinarsi, e quindi un scegliere in base alla conoscenza di ciò che scelgo. È la verità circa il bene e il male la radice della libertà. Il pensare che la libertà della persona possa nascere come per generazione spontanea da un terreno incolto, e che pertanto vada evitata ogni coltivazione della persona, è ignorare completamente i grandi dinamismi dello spirito.
4. Che cosa muove una persona ad interessarsi del bene di un’altra nel modo proprio dell’educazione? Nulla, se non volere il bene del persona bisognosa di educazione. Cioè: l’amore per essa. L’atto educativo è sempre frutto di amore: “un affare del cuore”, diceva S. Giovanni Bosco.
Esiste in natura una condivisione originaria del destino, del bene dell’altro: la relazione genitori-figlio. È questa la ragione profonda per cui educare la persona è il compito e la responsabilità dei genitori. Altri possono avere compiti e responsabilità educative, ma solamente su delega dei genitori. E pertanto sono da considerarsi non sostituti, ma cooperatori dei genitori medesimi.
Esiste anche una condivisione del destino della persona che è propria della Chiesa. Gesù dice, prima di lasciare visibilmente questo mondo: “Andate dunque ed ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato” [Mt 28,19-20a]. È mediante la Chiesa che Cristo realizza la sua opera redentiva. In questa prospettiva anche la Chiesa ha un compito ed una responsabilità educativa propria ed originaria. Ma essa è di natura diversa di quella della famiglia.
Solo se il genitore intende educare nella fede cristiana il proprio figlio, deve chiedere alla Chiesa – non ad altri – di collaborare e di aiutarlo. La Chiesa, infatti, da quando esiste ha educato; ha pensato e vissuto la propria missione come missione educativa. Ed uno degli strumenti fondamentali di cui si è ben presto dotata, è stata la scuola. Impedire alla Chiesa di educare è impedire alla Chiesa di esistere.
Anche lo Stato ha una responsabilità. Ma è di natura completamente diversa. Esso non ha, non deve e non può avere un compito ed una responsabilità educativa: sarebbe la dittatura. È accaduto storicamente. Lo Stato ha solo un ruolo sussidiario: favorire l’esercizio della libertà educativa dei genitori, e la libera proposta educativa. Esso deve intervenire in “prima persona” solo quando e solo dove diventa necessario per tutelare il diritto delle giovani generazioni ad essere educate.
5. Da che cosa oggi l’opera educativa è insidiata, e quindi su che cosa chi ha responsabilità educativa deve vigilare?
In primo luogo deve vigilare che non entri nei luoghi dell’educazione la falsa visione della persona umana che confonde libertà e spontaneità: la spontaneità può essere solo regolamentata; la libertà può essere educata.
In secondo luogo deve vigilare che non sia distrutto il principio di autorità, senza del quale ogni opera educativa è destinata al fallimento. Il rapporto educativo non è fra uguali. L’educatore ha una sua propria autorità che consiste: a) nel fare una precisa proposta di vita; b) nel documentarne la verità e la bontà mediante la testimonianza della vita. Si potrebbe anche dire che l’autorità propria dell’educatore ha la caratteristica propria della testimonianza.
In terzo luogo deve vigilare sul non ridurre l’educazione alla formazione, al know-how come si dice oggi. È una modalità di vita che è trasmessa dall’educatore.
Termino con un riferimento a ciò che accadde nella Chiesa antica, ma che resta paradigmatico per noi anche oggi. Essa [soprattutto con Origene] ha avuto la grande intuizione che la proposta cristiana era l’adempimento e il grado più alto della “paideia” dell’uomo. “Riprendendo questa idea fondamentale e dandone una propria interpretazione, la religione cristiana si mostrò capace di offrire al mondo più di qualsiasi altra setta religiosa” [W. Jaeger, Cristianesimo primitivo e paideia greca, La Nuova Italia ed., Firenze 1966, pag. 93]. L’annuncio del Vangelo aveva individuato la struttura umana in cui radicarsi: l’uomo è un essere che raggiunge la pienezza della sua umanità solo mediante l’educazione. Ed è nella luce di una tale verità antropologica che la Chiesa si prende cura dell’uomo.
“Creati per amare: la verità e la bellezza dell’amore”
Relazione del Card. Carlo Caffarra a Rocca di Papa, 24 marzo 2010
Dividerò la mia riflessione in due parti. Nella prima, vorrei molto semplicemente presentare la visione cristiana dell’amore; nella seconda richiamare l’attenzione su ciò che oggi insidia questa visione nella cultura occidentale e nel cuore di un giovane.
1. La visione cristiana dell’amoreInizio da un testo di K. Wojtyla desunto dalla sua opera drammatica La bottega dell’orefice: “Non esiste nulla che più dell’amore occupi sulla superficie della vita umana più spazio, e non esiste nulla che più dell’amore sia sconosciuto e misterioso. Divergenza tra quello che si trova sulla superficie e quello che è il mistero dell’amore: ecco la fonte del dramma. Questo è uno dei grandi drammi dell’esistenza umana” [In Tutte le opere letterarie, Bompiani ed., Milano 2001, pag. 821].
Noi vogliamo questa mattina entrare in questo “grande dramma dell’esistenza umana”, per scoprire la via che conduce l’uomo fuori dalla “divergenza” e dalla dilacerazione fra “quello che si trova sulla superficie” e quello che è “il mistero dell’amore”. Vorrei percorrere con voi un vero e proprio itinerario della mente verso la verità e la bellezza dell’amore.
1,1. – Il punto di partenza è singolare ed in un certo senso sconvolgente. Quando la proposta cristiana parla di amore, non parla in primo luogo e principalmente dell’uomo, di un vissuto umano. Parla dello stesso mistero di Dio. Il soggetto del discorso cristiano circa la verità e la bellezza dell’amore non è l’uomo ma Dio stesso. Alla domanda “che cosa è l’amore”, la fede cristiana risponde: è la condotta di Dio verso l’uomo e la radice di questa condotta. La narrazione di questa condotta, e quindi la rivelazione della sua intima verità e bellezza, è la S. Scrittura; ed il vertice di questa rivelazione è Gesù Cristo.
C’è la possibilità per la persona umana di contemplare la bellezza di questo amore e di conoscerne la verità? In realtà, c’è una sola possibilità, una sola via che ci porta alla conoscenza della verità dell’amore: sperimentare l’amore.
L’esperienza dell’amore di Dio per l’uomo in Cristo è ciò che mi consente di conoscerlo. Questa esperienza ha come due aspetti. Dal punto di vista dell’oggetto, l’amore di Dio in Cristo deve mostrarsi indirizzato a me [“mi ha amato e ha dato se stesso per me”]. Dal punto di vista del soggetto deve esserci una attitudine di attesa, di domanda [la S. Scrittura, la narrazione obiettiva dell’amore di Dio, termina con un’invocazione: “vieni”]. “La risposta della ragione all’avvenimento appare ultimamente come una domanda, per l’indigenza essenziale che la caratterizza nella sua stessa vitalità: vieni!” [C. Di Martino, La conoscenza è sempre un avvenimento, Mondadori Università, Milano 2009, pag. 33].
Alla domanda pertanto se l’uomo possa conoscere la verità dell’amore potrei rispondere dicendo che l’unica possibilità è sentirsi amato. Teologicamente rispondo: l’unica possibilità è ricevere in sé lo Spirito Santo.
Esiste però un “luogo” in cui il mistero dell’amore di Dio in Cristo si dona all’uomo? Esiste, ed è la celebrazione dell’Eucaristia. Tommaso arriverà quindi a scrivere: “in questo sacramento è la sintesi di tutto il mistero della nostra salvezza” [3,83,4]. La conoscenza per esperienza [non è possibile un’altra] ha la sua sorgente nella partecipazione all’Eucaristia. È una conoscenza mediante l’Eucaristia.
L’amore che Dio in Cristo nutre per l’uomo per farsi capire ha bisogno di dirsi in un linguaggio umano. E così è accaduto. Dio ha detto all’uomo il suo amore servendosi del linguaggio dell’amore coniugale, dell’amore parentale [paterno e materno], dell’amore di amicizia.
Questo triplice linguaggio è però come attraversato da un significato che lo trascende smisuratamente. Questo triplice linguaggio veicola un significato che lo rende indicativo di una realtà che non ha paragoni [“chi è pari al Signore nostro Dio?”]: la gratuità, la pura gratuità. È questa la cifra propria dell’amore di Dio. Tommaso dice profondamente che il primo dono che Dio ci ha fatto è di aver deciso di amarci; e tutti gli altri doni sono una conseguenza. E decidere di amarci significa decidere di comunicare Se stesso all’uomo, la sua Vita stessa.
Tuttavia “gratuità” non significa “indifferenza alla risposta” dell’uomo: un Dio che non mi desidera e veramente non si appassiona per la mia risposta, non mi amerebbe veramente. L’amore di Dio in Cristo è gratuità e desiderio.
1,2. – La Rivelazione cristiana quando parla dell’amore non parla però soltanto dell’amore di Dio. Come scrive Benedetto XVI, “la fede biblica non costruisce un mondo parallelo o un mondo contrapposto rispetto a quell’originario fenomeno umano che è l’amore, ma accetta tutto l’uomo intervenendo nella sua ricerca di amore per purificarla, dischiudendogli al contempo nuove dimensioni” [Lett. Enc. Deus caritas est 8].
Questo testo è assai importante. Esso fa tre affermazioni fondamentali: l’amore è un fenomeno umano originario ; la rivelazione biblica ha una funzione purificatrice; la medesima ha una funzione elevante. Brevemente: la capacità di amore è costitutiva della persona umana, ma essa ha bisogno di essere sanata ed elevata.
Esiste un testo di S. Basilio che ci può aiutare ad una comprensione profonda di tutto questo. Esso dice: “abbiamo insita in noi, fin dal primo momento in cui siamo plasmati, la capacità di amare. E la prova di questo non viene dall’esterno, ciascuno può rendersene conto da sé e dentro di sé. Di ciò che è buono infatti proviamo naturalmente desiderio” [Le regole, Ed. Qiqaion, Bose 1993, pag. 79]. L’esperienza che ciascuno ha in sé dell’amore è di un desiderio, di un movimento [ad-petitus] verso ciò che è buono, verso ciò che è bello. Il tempo a disposizione non mi consente di approfondire questa definizione di amore – l’amore è il desiderio naturale del bene – come meriterebbe. Mi limito ad alcune osservazioni fondamentali.
Quando si dice “bene” [“di ciò che è buono … proviamo naturalmente desiderio”] si intende qualcosa/qualcuno che ha in sé una perfezione tale [morale, estetica, fisica …] da non lasciarci indifferenti, da attirare la nostra attenzione, da suscitare in noi e motivare una risposta [von Hildebrandt la chiama Beruehrens-beziehung]. Il nostro desiderio è sempre risposta a qualcosa/qualcuno che ha in sé ragione di essere desiderato.
Quando però parliamo di amore intendiamo la risposta [nel senso suddetto] di una persona ad una persona: è una relazione inter-personale. Ma nel senso forte: non solo a causa dei valori [morali, estetici, fisici…] posseduti dalla persona, ma è relazione alla persona stessa come tale.
È una risposta spirituale, che implica cioè la conoscenza-valutazione [del valore] della persona: non del tipo stimolo-risposta, bisogno-soddisfazione.
È una risposta del cuore, eminentemente affettiva: per dire con verità “amo” non basta dire “voglio amare”. È un coinvolgimento della persona trasportata verso l’altra.
E quindi è una risposta che implica il desiderio unitivo; che desidera la felicità della persona amata; ed anela ad essere corrisposto.
Platone per primo ha visto profondamente che l’amore – lo possiamo ora definire: la risposta affettiva al valore [della], che è la persona dell’altro, fatta propria dalla libertà – ha in sé un enigmatico paradosso: è figlio di Póros, la ricchezza, e di Penía, la povertà. Il paradosso consiste nella tensione insita nell’amore al dono di sé, da una parte; e dall’altra, nella tensione che l’altro corrisponda, che l’altro accetti il dono, vi corrisponda donandosi. L’intenzione oblativa sembra contrariare l’intenzione possessiva.
Il S. Padre scrive, come abbiamo visto, che tutto l’uomo è accettato: dunque ambedue le intenzioni sono costitutive dell’amore umano. Nessuna delle due va negata. È questa dialettica fra oblazione e possesso che costituisce il punto di aggancio nell’uomo della rivelazione biblica dell’amore con l’amore in quanto originario fenomeno umano.
Per comprendere ciò partiamo da un testo paolino che recita: “la speranza non delude, poiché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato donato” [Rom 5,5].
L’amore di Dio non significa: l’amore con cui noi amiamo Dio; ma significa: con cui Dio ama noi. Si parla dunque dell’amore divino stesso.
Di esso l’Apostolo dice che è stato “riversato nei nostri cuori”. Dio fa “sentire” l’amore – la sua misura e la sua qualità – che nutre per noi: ce ne dona l’esperienza. Non solo nel senso che ce lo fa conoscere: il testo non dice lo “riversa nella mente”. Ma nel senso che lo fa sentire in quello che è l’organo proprio dell’amore, il cuore, che è la sintesi nell’io-persona di intelligenza, libertà, affettività. Il cuore dell’uomo diventa partecipe dell’amore con cui Dio ama.
Questa partecipazione è dovuta ad un fatto: il dono dello Spirito Santo che viene ad abitare nel cuore. È la divina persona dello Spirito la nostra partecipazione allo stesso amore con cui Dio ama. Nel senso che noi diventiamo partecipi dell’amore divino in quanto lo Spirito Santo diventa “possessore” del nostro cuore, della nostra capacità di amare.
È questa “spiritualizzazione” che purifica il nostro amore e gli dischiude nuove dimensioni: tutto l’umano è salvato, custodito ed elevato. S. Ireneo scrive: “gli uomini sono spirituali grazie alla partecipazione dello Spirito, ma non grazie alla privazione ed eliminazione della carne” [adv Haereses V, 6; SCh 153, pag. 74].
Il desiderio di possedere la persona umana è integrato nel movimento di auto-donazione nella medesima. Non è negato, ma custodito nella sua verità più profonda.
Concludo questo primo punto. Due sono le dimensioni essenziali dell’idea cristiana di amore. Essa esprime il volto del mistero di Dio: Dio nel suo mistero e nella rivelazione che fa di Sé è amore. Essa esprime il mistero dell’uomo: la persona umana è resa capace di amare come Dio stesso ama, senza essere “privata della carne”.
2. L’amore insidiatoIn questa seconda parte della mia riflessione vorrei riflettere, brevemente, su ciò che insidia oggi il cuore del giovane impedendogli, o comunque rendendo assai difficoltosa, la comprensione della visione cristiana dell’amore.
Perché l’annuncio cristiano dell’amore trovi il terreno in cui radicarsi, la persona che l’ascolta deve possedere una vera coscienza di se stessa e vivere una conseguente esperienza di libertà. Fra le due realtà – coscienza di sé e modo di essere liberi – c’è una connessione inscindibile e come una sorta di reciproca inabitazione.
Ora la coscienza di sé nel mondo occidentale è andata progressivamente oscurandosi, nel senso che il “sé” si è come nascosto agli occhi della coscienza in ciò che ha di più nobile e proprio. Che cosa è accaduto? Che “vittime dello scientismo, non crediamo più in noi stessi, chi e che cosa siamo, quando ci lasciamo persuadere di essere soltanto macchine per la diffusione dei nostri geni, quando consideriamo la nostra ragione soltanto come prodotto di un adattamento evolutivo, che non ha nulla a che fare con la verità” [R. Spaemann]. La soggettività sostanziale della persona è andata progressivamente “rottamata”.
La prima conseguenza di questa “rottamazione del’io” è la deformazione della relazione con l’altro: una relazione ridotta a stimolo-risposta. L’io rottamato, direbbe Hume, è incapace di fare un passo oltre se stesso. Il segno più evidente di questa condizione è la riduzione della libertà a spontaneità.Esiste una differenza sostanziale fra l’una e l’altra: la libertà non è una spontaneità … più spontanea! È un modo di agire essenzialmente diverso. Il tema esigerebbe una lunga riflessione. Mi limito a due riflessioni.
Ciò che distingue agire libero e agire spontaneo è che il primo rivela la trascendenza della persona sul suo agire e nel suo agire. È la persona che decide di agire, al di sopra ed anche contro ciò che accade nella sua psiche. La nostra lingua italiana ha due espressioni che ci aiutano a capire: “io voglio” ha un significato profondamente diverso da “mi viene voglia”. Col primo denoto l’esperienza della persona che decide auto-determinandosi; nel secondo denoto piuttosto un essere-determinati ad agire da qualcosa d’altro.
La seconda riflessione per cogliere la diversità fra libertà e spontaneità è ancora più importante. L’atto del volere [“io voglio”] è sempre intenzionale: è cioè rivolto ad un oggetto [per es. “voglio studiare”]. La persona si determina ad agire poiché riconosce in ciò che vuole [“studiare piuttosto che divertirsi”] una bontà intrinseca all’oggetto voluto, un “valore” suo proprio [“è bene che io ora studi”]. L’autodeterminazione e la trascendenza della persona è fondata e condizionata dalla conoscenza, dalla relazione della persona con la verità sul bene. La radice di tutta la libertà, scrisse S. Tommaso, è il giudizio della ragione. L’affermazione teorica e pratica della libertà; la costituzione dell’io che agisce; la capacità dell’uomo di conoscere la verità circa il bene, stanno e cadono insieme.
Proviamo ora a riassumere quanto detto finora. Mi ero chiesto: che cosa insidia oggi la capacità di un giovane di ascoltare la proposta cristiana dell’amore? Ho risposto: la rottamazione cui è stato sottoposto il suo io. Una rottamazione che ha deformato la relazione dell’altro, riducendola ad una relazione spontanea e non libera: “mi viene voglia di relazionarmi a …”; e non “io voglio relazionarmi a …”. E l’amore può essere solo libero; solo la persona libera è capace di amare.
Non procedo oltre su questi temi, poiché altri li riprenderanno, e vengo alla conclusione.
Da ciò che ho detto si deve concludere che il destino della proposta cristiana è la totale estraneità dalla coscienza che di sé ha l’uomo in Occidente? Si e no.
L’apostolo Paolo e l’apostolo Giovanni insistono con grande forza sulla estraneità, anzi sul contrasto che vige fra il Vangelo e il mondo. Ma quando dicono questo, i due apostoli pensano che dentro alla creazione si è costituita un anti-creazione. E l’uomo nasce collocato nella seconda: nasce radicato nella solidarietà ingiusta con Adamo.
Ma è questo il vero uomo? o questi non è piuttosto l’uomo estraneo a se stesso? La proposta cristiana è rivolta all’uomo perché ritorni nella verità della sua prima origine. È dono di grazia che rigenera, poiché è l’uomo in Cristo che non “vive più per se stesso” [cfr. Rom 14,8], che diventa capace di amare. Alla fine: proporre l’amore è proporre di convertirsi a Cristo e di vivere in Lui. Solo così l’uomo ritrova se stesso, perché ritrova la capacità di amare. “Poiché solo nell’amore l’uomo si desta alla sua piena esistenza personale, solo nell’amore egli attualizza la totale pienezza della sua essenza” [D. von Hildebrandt, Man and Woman, Franciscan Herald Press, Chicago 1986, pag. 32].
“Matrimonio e unioni omosessuali”
Card. Carlo Caffarra, Nota Dottrinale del 14 febbraio 2010
La presente Nota si rivolge in primo luogo ai fedeli perché non siano turbati dai rumori mass-mediatici. Ma oso sperare che sia presa in considerazione anche da chi non-credente intenda fare uso, senza nessun pregiudizio, della propria ragione.
1. Il matrimonio è uno dei beni più preziosi di cui dispone l’umanità. In esso la persona umana trova una delle forme fondamentali della propria realizzazione; ed ogni ordinamento giuridico ha avuto nei suoi confronti un trattamento di favore, ritenendolo di eminente interesse pubblico.
In Occidente l’istituzione matrimoniale sta attraversando forse la sua più grave crisi. Non lo dico in ragione e a causa del numero sempre più elevato dei divorzi e separazioni; non lo dico a causa della fragilità che sembra sempre più minare dall’interno il vincolo coniugale: non lo dico a causa del numero crescente delle libere convivenze. Non lo dico cioè osservando i comportamenti.
La crisi riguarda il giudizio circa il bene del matrimonio. È davanti alla ragione che il matrimonio è entrato in crisi, nel senso che di esso non si ha più la stima adeguata alla misura della sua preziosità. Si è oscurata la visione della sua incomparabile unicità etica.
Il segno più manifesto, anche se non unico, di questa “disistima intellettuale” è il fatto che in alcuni Stati è concesso, o si intende concedere, riconoscimento legale alle unioni omosessuali equiparandole all’unione legittima fra uomo e donna, includendo anche l’abilitazione all’adozione dei figli.
A prescindere dal numero di coppie che volessero usufruire di questo riconoscimento – fosse anche una sola! – una tale equiparazione costituirebbe una grave ferita al bene comune.
La presente Nota intende aiutare a vedere questo danno. Ed anche intende illuminare quei credenti cattolici che hanno responsabilità pubbliche di ogni genere, perché non compiano scelte che pubblicamente smentirebbero la loro appartenenza alla Chiesa.
2. L’equiparazione in qualsiasi forma o grado della unione omosessuale al matrimonio avrebbe obiettivamente il significato di dichiarare la neutralità dello Stato di fronte a due modi di vivere la sessualità, che non sono in realtà ugualmente rilevanti per il bene comune.
Mentre l’unione legittima fra un uomo e una donna assicura il bene – non solo biologico! – della procreazione e della sopravvivenza della specie umana, l’unione omosessuale è privata in se stessa della capacità di generare nuove vite. Le possibilità offerte oggi dalla procreatica artificiale, oltre a non essere immuni da gravi violazioni della dignità delle persone, non mutano sostanzialmente l’inadeguatezza della coppia omosessuale in ordine alla vita.
Inoltre, è dimostrato che l’assenza della bipolarità sessuale può creare seri ostacoli allo sviluppo del bambino eventualmente adottato da queste coppie. Il fatto avrebbe il profilo della violenza commessa ai danni del più piccolo e debole, inserito come sarebbe in un contesto non adatto al suo armonico sviluppo.
Queste semplici considerazioni dimostrano come lo Stato nel suo ordinamento giuridico non deve essere neutrale di fronte al matrimonio e all’unione omosessuale, poiché non può esserlo di fronte al bene comune: la società deve la sua sopravvivenza non alle unioni omosessuali, ma alla famiglia fondata sul matrimonio.
3. Un’altra considerazione sottopongo a chi desideri serenamente ragionare su questo problema.
L’equiparazione avrebbe, dapprima nell’ordinamento giuridico e poi nell’ethos del nostro popolo, una conseguenza che non esito definire devastante. Se l’unione omosessuale fosse equiparata al matrimonio, questo sarebbe degradato ad essere uno dei modi possibili di sposarsi, indicando che per lo Stato è indifferente che l’uno faccia una scelta piuttosto che l’altra.
Detto in altri termini, l’equiparazione obiettivamente significherebbe che il legame della sessualità al compito procreativo ed educativo, è un fatto che non interessa lo Stato, poiché esso non ha rilevanza per il bene comune. E con ciò crollerebbe uno dei pilastri dei nostri ordinamenti giuridici: il matrimonio come bene pubblico. Un pilastro già riconosciuto non solo dalla nostra Costituzione, ma anche dagli ordinamenti giuridici precedenti, ivi compresi quelli così fieramente anticlericali dello Stato sabaudo.
4. Vorrei prendere in considerazione ora alcune ragioni portate a supporto della suddetta equiparazione.
La prima e più comune è che compito primario dello Stato è di togliere nella società ogni discriminazione, e positivamente di estendere il più possibile la sfera dei diritti soggettivi.
Ma la discriminazione consiste nel trattare in modo diseguale coloro che si trovano nella stessa condizione, come dice limpidamente Tommaso d’Aquino riprendendo la grande tradizione etica greca e giuridica romana: “L’uguaglianza che caratterizza la giustizia distributiva consiste nel conferire a persone diverse dei beni differenti in rapporto ai meriti delle persone: di conseguenza se un individuo segue come criterio una qualità della persona per la quale ciò che le viene conferito le è dovuto non si verifica una considerazione della persona ma del titolo” [2,2, q.63, a. 1c].
Non attribuire lo statuto giuridico di matrimonio a forme di vita che non sono né possono essere matrimoniali, non è discriminazione ma semplicemente riconoscere le cose come stanno. La giustizia è la signoria della verità nei rapporti fra le persone.
Si obietta che non equiparando le due forme lo Stato impone una visione etica a preferenza di un’altra visione etica.
L’obbligo dello Stato di non equiparare non trova il suo fondamento nel giudizio eticamente negativo circa il comportamento omosessuale: lo Stato è incompetente al riguardo. Nasce dalla considerazione del fatto che in ordine al bene comune, la cui promozione è compito primario dello Stato, il matrimonio ha una rilevanza diversa dall’unione omosessuale. Le coppie matrimoniali svolgono il ruolo di garantire l’ordine delle generazioni e sono quindi di eminente interesse pubblico, e pertanto il diritto civile deve conferire loro un riconoscimento istituzionale adeguato al loro compito. Non svolgendo un tale ruolo per il bene comune, le coppie omosessuali non esigono un uguale riconoscimento.
Ovviamente – la cosa non è in questione – i conviventi omosessuali possono sempre ricorrere, come ogni cittadino, al diritto comune per tutelare diritti o interessi nati dalla loro convivenza.
Non prendo in considerazione altre difficoltà, perché non lo meritano: sono luoghi comuni, più che argomenti razionali. Per es. l’accusa di omofobia a chi sostiene l’ingiustizia dell’equiparazione; l’obsoleto richiamo in questo contesto alla laicità dello Stato; l’elevazione di qualsiasi rapporto affettivo a titolo sufficiente per ottenere riconoscimento civile.
5. Mi rivolgo ora al credente che ha responsabilità pubbliche, di qualsiasi genere.
Oltre al dovere con tutti condiviso di promuovere e difendere il bene comune, il credente ha anche il grave dovere di una piena coerenza fra ciò che crede e ciò che pensa e propone a riguardo del bene comune. È impossibile fare coabitare nella propria coscienza e la fede cattolica e il sostegno alla equiparazione fra unioni omosessuali e matrimonio: i due si contraddicono.
Ovviamente la responsabilità più grave è di chi propone l’introduzione nel nostro ordinamento giuridico della suddetta equiparazione, o vota a favore in Parlamento di una tale legge. È questo un atto pubblicamente e gravemente immorale.
Ma esiste anche la responsabilità di chi dà attuazione, nella varie forme, ad una tale legge. Se ci fosse bisogno, quod Deus avertat, al momento opportuno daremo le indicazioni necessarie.
È impossibile ritenersi cattolici se in un modo o nell’altro si riconosce il diritto al matrimonio fra persone dello stesso sesso.
Mi piace concludere rivolgendomi soprattutto ai giovani. Abbiate stima dell’amore coniugale; lasciate che il suo puro splendore appaia alla vostra coscienza. Siate liberi nei vostri pensieri e non lasciatevi imporre il giogo delle pseudo-verità create dalla confusione mass-mediatica. La verità e la preziosità della vostra mascolinità e femminilità non è definita e misurata dalle procedure consensuali e dalle lotte politiche.
Bologna, 14 febbraio 2010 Festa dei Santi Cirillo e Metodio Compatroni d’Europa
Lettera Pastorale di S.E. Mons. Luigi Negri alle Famiglie della Diocesi in occasione della Quaresima 2010
Famiglia, diventa quello che sei!
Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio, n. 7
Carissimi fedeli della Chiesa particolare di San Marino-Montefeltro, Vi invio questa mia quinta lettera pastorale di Quaresima nel vivo della Visita Pastorale che ho compiuto in oltre la metà delle nostre comunità, ecclesiali e sociali.
La Visita Pastorale è stata ed è, per me, un’esperienza faticosa ma realmente esaltante: è stato ed è un incontro con questo popolo che il Papa ha affidato al mio servizio episcopale. Incontro con tutto questo popolo, nelle sue varie dimensioni di pensiero e di vita: dal cuore profondo della sua intelligenza e della sua affezione, alle espressioni della vita quotidiana, in tutti gli aspetti di grandezza e di miseria, di gioia e di dolore, di salute e di malattia, nelle varie stagioni della vita, dall’infanzia alla maturità ed alla vecchiaia.
Mi sono sentito “atteso” da tutti ed in questa attesa mia e vostra mi sono incontrato con ciascuno di voi e con tutti: e questo incontro è stato ed è per me un’esperienza carica di compassione e di grandissima affezione umana e cristiana.
Il nostro popolo sente con nostalgia il fascino della fede
Il cuore profondo del nostro popolo, sente più che mai vivo il fascino della fede: e ne vive una profonda nostalgia. Nostalgia della fede che, in questi luoghi, ha saputo creare un autentico “umanesimo cristiano”, che si è espresso in una autentica cultura di popolo, in un ethos, quello della carità che è stato ed è ancora ampiamente praticato. Questo umanesimo si è espresso in una produzione artistica e culturale che è ancora il vanto del nostro popolo e rende così “belli” i nostri luoghi di vita e di socialità. Molti, moltissimi (e non solo i più anziani) mi hanno chiesto di aiutarli a rivivere questa grande tradizione di fede e di vita nell’oggi della nostra esistenza; ma per altri, purtroppo molti altri, mi pare che la tradizione sia una pagina chiusa, un fatto “archiviato”.
Nell’incontro con i giovani, nella scuola, negli ambienti della vita quotidiana ho creduto di percepire una fondamentale lontananza dalla fede; la fede ed i suoi valori sembrano essere lontani dal cuore e dalle attese di molti, certamente di troppi.
Troppe volte la fede rimane un fondamento chiuso in sé e, pertanto, inesorabilmente astratto, così la mentalità con cui molti, certamente troppi, vivono è la mentalità di questo mondo, non solo lontana, ma programmaticamente ostile alla fede ed alla Chiesa.
La famiglia
Luogo dove si impara a vivere la fede
Fratelli, mi sento di riproporre anche a Voi oggi il grande invito che san Paolo rivolgeva ai nostri primi fratelli: non vogliate conformarvi alla mentalità di questo mondo (Rom 12,2).
Il luogo in cui questa dialettica quotidiana fra la tradizione e la mentalità laicistica, individualista ed edonista si vive è la famiglia: la questione della famiglia è pertanto questione sostanziale per la Chiesa e per tutta la società, da approfondire teoricamente e soprattutto da vivere praticamente, nella quotidianità della vita.
Il destino della Chiesa legato a quello della famiglia
Questa lettera pastorale è il mio contributo ad affrontare i problemi della famiglia nella sua valenza cristiana e naturale.
Il destino della Chiesa è legato al destino della famiglia ed il destino della famiglia è legato al destino della Chiesa, secondo la potente verità esplicitata dal Concilio Vaticano II che ha riconosciuto la famiglia come Chiesa domestica. La famiglia cristiana rende presente la Chiesa nel mondo, come fatto sociale di vita, di cultura, di moralità, di intrapresa culturale e sociale.
Questa presenza della famiglia cristiana riconosce e valorizza adeguatamente quella realtà di famiglia naturale che, storicamente, ha preceduto l’esperienza della famiglia cristiana e che per millenni è stata l’elemento fondamentale e propulsivo dell’intera vita sociale; per millenni la società e la civiltà, soprattutto la nostra civiltà occidentale, sono nate come fatto ed espressione della presenza della famiglia.
Ora della famiglia, sia cristiana che naturale, la mentalità mondana e la politica che la esprime progettano la definitiva distruzione e pertanto il suo irreversibile superamento.
La famiglia è stata ed è un fattore vivo di radicale contestazione dell’individualismo che domina la vita della società a tutti i livelli.
Per la mentalità che domina questa nostra società alla base della vita sociale c’è l’individuo, che tende ad esprimere la sua vera natura, cioè il suo potere, manipolando tutta la realtà in funzione del proprio benessere. Un individuo che vive la vita come immediata espressione delle proprie capacità di conoscenza e di manipolazione della realtà, anche quella umana, in funzione del proprio benessere individuale.
La famiglia non è, invece, la somma di due individui o la pretesa di un individuo che tenta di imporsi all’altro; la famiglia nasce da un gesto sostanziale di verità e di gratuità. L’uomo appare, nell’orizzonte della coscienza della donna e viceversa, come una “presenza” carica di promessa e di aiuto a compiere il cammino della propria vicenda umana, verso la pienezza del proprio io, per il compimento della propria felicità.
“Mostrami un’amante che sia pur bellissima, a che servirà la sua bellezza se non come un segno dove io legga il nome di colei che di quella bellissima è più bella?” (Shakespeare, Romeo e Giulietta, Atto I, Scena I).
La famiglia nasce da un impegno di persone che tendono a realizzare nel mondo un evento di verità, di libertà, di gratuità e di compassione.
Il Sacramento del Matrimonio conferma il massimo di profondità teorica alle intuizioni ed alle certezze naturali e fornisce quell’aiuto di Grazia che è la presenza sacramentale del Signore risorto, insostituibile sostegno e fondamento di ogni compagnia coniugale.
La famiglia cristiana nasce dal senso del mistero di Dio
Se la famiglia vive della sua verità rappresenta un luogo reale nella società e nella storia, in cui l’individualismo e l’egoismo vengono inesorabilmente contraddetti, non da un’ideologia astratta ma da una esperienza di vita nuova.
La famiglia è un evento di conoscenza e di amore reciproco, che diviene corresponsabilità e dedizione, che si apre alla generazione ed educazione dei figli, in una partecipazione reale e quotidiana alla grande missione della Chiesa, di cui la famiglia cristiana è chiamata ad essere protagonista.
Figli carissimi, questa è la famiglia, che liberamente avete deciso di riconoscere ed attuare fra di Voi nella Chiesa, tanti o pochi anni fa; questa è la famiglia che vi state preparando a riconoscere e ad attuare: una realtà che nasce dal senso del Mistero di Dio o dalla certezza della presenza definitiva di Dio in Gesù Cristo.
Essa, con la sua vita quotidiana, parla di Dio e di Cristo a tutti gli uomini. La famiglia non è la somma di due egoismi che convivono solo per il tempo in cui questi egoismi tentano di assicurare l’uno all’altro un certo benessere, in tutti i campi, da quello affettivo, a quello psicologico, culturale, economico, sessuale ed altro e si scioglie quando questo benessere non può più essere assicurato. Convivenze temporanee e sostanzialmente irresponsabili negano il dinamismo fondamentale della persona, che è la conoscenza e l’amore e quindi minano le basi della società, il suo dinamismo di vita, di verità e di affezione. Le convivenze a tempo, alla mercé cioè dei gusti, degli istinti e delle pretese sono umanamente brutte, come risulta essere brutta la vita di tutti i giorni in questa nostra società, che rifiutando Cristo non riesce a non rifiutare se stessa.
Fratelli, questa è la famiglia, questa è la famiglia cristiana e questa è la radicale contestazione della mentalità individualistica ed edonistica che essa porta con sé. È necessario conoscere l’identità della famiglia ma è altrettanto importante viverla ed attuarla, nella società e nella storia. Nel grande documento sulla famiglia, la Familiaris Consortio al n. 7, Giovanni Paolo II scriveva: Famiglia, diventa quello che sei!
La nostra Chiesa particolare in questo anno 2010 intende assumere una precisa responsabilità nei confronti di tutte le famiglie, aiutandole a diventare quello che sono, assumendo il lavoro quotidiano di attuare nella vita quello che si è celebrato e costituito nel Sacramento.
Per un contributo alla vita delle famiglie
Lungo quali direzioni si muoveranno la vita e l’attività della nostra Diocesi in rapporto alle famiglie?
1. La straordinaria identità della famiglia
La prima direttiva consiste nel richiamare il popolo cristiano alla straordinarietà di questa esperienza di comunione totale, nella cui unità di uomo e donna i coniugi sono chiamati a fare esperienza della presenza di Cristo e dell’appartenenza a Lui.
È necessario aiutare gli sposi, mentre si preparano al matrimonio, a recuperare il valore della sacramentalità del matrimonio stesso, cioè del riferimento totale della famiglia a Cristo e della sua apertura alla vita della Chiesa.
Si tratta di riconoscere l’avvenimento di fede e comunione, la fecondità e la laboriosità che contraddicono la logica mondana.
2. È necessaria una educazione
Sia nella fase della preparazione al matrimonio, sia nella vita matrimoniale, occorre fare esperienza di appartenenza alla Chiesa. La famiglia infatti è se stessa perché appartiene alla Chiesa e quindi fa della Chiesa il suo riferimento fondamentale.
Sul piano intellettuale, morale, affettivo, psicologico le famiglie devono sentirsi parte viva della Chiesa e devono riconoscere che la loro vocazione specifica è quella di fare esperienza di Chiesa nella famiglia e di offrire questa stessa esperienza a quanti si accostano.
A) La cultura
Occorre sviluppare una concezione della famiglia come luogo dove i criteri fondamentali della fede si imparano e si approfondiscono, e quindi tendono a costituire una cultura.
La famiglia deve diventare un luogo dove questa mentalità di fede, imparata, viene attuata, giudicando e partecipando alla vita della società con una visione originale.
In questa cultura è fondamentale l’affermazione della sacralità della vita e della sua indisponibilità a tutti tranne che a Dio: il riconoscimento del dovere della paternità e maternità responsabili; la responsabilità educativa nei confronti delle vite nuove fino ad un intervento sociale e politico perché il diritto-dovere fondamentale della famiglia all’educazione venga sempre più riconosciuto ed attuato e non, come ricordava al Convegno di Verona Benedetto XVI, ancora così troppo ampiamente disatteso.
B) La carità
Un rapporto nuovo che scaturisce dal Mistero di Cristo e lega ogni persona ed ogni avvenimento al Suo Mistero. È carità vissuta all’interno della famiglia che la spalanca a riconoscere, accogliere, condividere, tutti i bisogni della società.
Non posso non dire tutto il mio plauso per la grande esperienza di capacità di accoglienza che centinaia di famiglie cristiane mi hanno testimoniato in questi anni; come non posso non ricordare il sacrificio economico sostenuto da moltissime famiglie per la creazione di scuole libere, nelle quali bambini, ragazzi e giovani sono aiutati a conquistare un sapere oggettivo, che li aiuta in modo sostanziale al compimento della loro personalità.
È la fecondità della famiglia cristiana che non si è concepita individualisticamente, ma ha fatto vibrare nel quotidiano della sua esperienza l’amore all’uomo di questo tempo, nella capacità di condividerne i bisogni e le difficoltà.
C) La missione
La famiglia deve concepirsi, obiettivamente, nell’orizzonte della missione cristiana, servendo la missione della Chiesa, avendo come orizzonte, nel particolare, l’universale, secondo la grande intuizione di Pio XII: «Le prospettive universali della Chiesa sono le dimensioni normali della vita del cristiano» (Cfr. Fidei Donum).
Figli carissimi, ci aspetta un grande compito: le famiglie della nostra Diocesi (sia chi si prepara al matrimonio, sia chi lo vive, da poco o tanto tempo, come comunione di gioia e fatica) devono sentirsi potentemente richiamate alla verità e gratuità della loro identità, per attuarla con tutta l’intelligenza e il cuore di cui sono capaci, perché è attraverso la testimonianza della famiglia cristiana che il mondo può capire che cosa sia il Mistero di Cristo e come esso cambia il cuore e la vita degli uomini.
Mi permetto di suggerire alcune occasioni e strumenti da tenere presenti in questo lavoro. È necessario valorizzare la catechesi delle famiglie; occorre favorire tentativi di “compagnia tra le famiglie” che costituiscano il luogo dove il vissuto quotidiano è messo in comune e, perciò, reso più vivibile; occorre usare adeguatamente i mezzi della comunicazione sociale, soprattutto quelli cattolici, per una presenza sempre più incisiva nella società, con particolare riferimento alla realtà della scuola. Ricordo a tutto il clero la grave responsabilità di comunicare al nostro popolo questa lettera pastorale e di curare tutto il lavoro di comprensione e di attuazione che mi auguro ne scaturisca.
Alla Beata Vergine delle Grazie, che dal lontano 1489 veglia maternamente sulla vita del nostro popolo, affido con umiltà e con tanta fiducia questa lettera pastorale, ma soprattutto il suo accoglimento e la sua attuazione nella vita di tutte le famiglie della nostra Diocesi.
Tutti benedico di cuore e a tutti chiedo preghiere per il mio servizio episcopale, per il bene e la prosperità di questa nostra antica, ma sempre viva comunità ecclesiale.
Pennabilli, gennaio 2010
Papa Benedetto XVI – Angelus del 27 Dicembre 2009
«La famiglia, icona di Dio»
Cari fratelli e sorelle!
Ricorre oggi la domenica della Santa Famiglia. Possiamo ancora immedesimarci nei pastori di Betlemme che, appena ricevuto l’annuncio dall’angelo, accorsero in fretta alla grotta e trovarono “Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia” (Lc 2,16). Fermiamoci anche noi a contemplare questa scena, e riflettiamo sul suo significato. I primi testimoni della nascita del Cristo, i pastori, si trovarono di fronte non solo il Bambino Gesù, ma una piccola famiglia: mamma, papà e figlio appena nato. Dio ha voluto rivelarsi nascendo in una famiglia umana, e perciò la famiglia umana è diventata icona di Dio! Dio è Trinità, è comunione d’amore, e la famiglia ne è, in tutta la differenza esistente tra il Mistero di Dio e la sua creatura umana, un’espressione che riflette il Mistero insondabile del Dio amore. L’uomo e la donna, creati ad immagine di Dio, diventano nel matrimonio “un’unica carne” (Gen 2,24), cioè una comunione di amore che genera nuova vita. La famiglia umana, in un certo senso, è icona della Trinità per l’amore interpersonale e per la fecondità dell’amore.
La liturgia odierna propone il celebre episodio evangelico di Gesù dodicenne che rimane nel Tempio, a Gerusalemme, all’insaputa dei suoi genitori, i quali, stupiti e preoccupati, ve lo ritrovano dopo tre giorni mentre discute con i dottori. Alla madre che gli chiede spiegazioni, Gesù risponde che deve “essere nella proprietà”, nella casa del suo Padre, cioè di Dio (cfr Lc 2,49). In questo episodio il ragazzo Gesù ci appare pieno di zelo per Dio e per il Tempio. Domandiamoci: da chi aveva appreso Gesù l’amore per le “cose” del Padre suo? Certamente come figlio ha avuto un’intima conoscenza del Padre suo, di Dio, una profonda relazione personale permanente con Lui, ma, nella sua cultura concreta, ha certamente imparato le preghiere, l’amore verso il Tempio e le Istituzioni di Israele dai propri genitori.
Dunque, possiamo affermare che la decisione di Gesù di rimanere nel Tempio era soprattutto frutto della sua intima relazione col Padre, ma anche frutto dell’educazione ricevuta da Maria e da Giuseppe. Qui possiamo intravedere il senso autentico dell’educazione cristiana: essa è il frutto di una collaborazione sempre da ricercare tra gli educatori e Dio. La famiglia cristiana è consapevole che i figli sono dono e progetto di Dio. Pertanto, non li può considerare come proprio possesso, ma, servendo in essi il disegno di Dio, è chiamata ad educarli alla libertà più grande, che è proprio quella di dire “sì” a Dio per fare la sua volontà. Di questo “sì” la Vergine Maria è l’esempio perfetto. A lei affidiamo tutte le famiglie, pregando in particolare per la loro preziosa missione educativa.
“L’esperienza della famiglia. Una bellezza da conquistare di nuovo”
di Julián Carrón
Incontro organizzato dal Centro Culturale di Milano in occasione della Settimana della Cultura 2009 della Diocesi di Milano
Un nuovo inizio
La famiglia è negli ultimi tempi al centro del dibattito pubblico. Il tentativo di regolare nuove forme di convivenza diverse dal matrimonio concepito come rapporto definitivo e fecondo tra un uomo e una donna ha scatenato una appassionata discussione. Non è qualcosa di totalmente nuovo, piuttosto è il culmine di un processo cominciato anni fa.
Questo dibattito ha messo in evidenza, da una parte, che tutta la propaganda di una mentalità contraria alla famiglia attraverso i media (cinema, televisione, stampa) pur avendo a disposizione mezzi così potenti non ha impedito che tante persone continuino a fare una esperienza positiva della famiglia. Davanti a questo impressionante spiegamento di forze mediatiche e ideologiche, parrebbe inevitabile che la famiglia smetta di interessare. Invece c’è un fatto che siamo costretti a riconoscere quasi con sorpresa: questo impressionante apparato ha dimostrato di non essere più potente dell’esperienza elementare che tanti di noi ha vissuto nella propria famiglia, l’esperienza inestirpabile di un bene. Un bene del quale siamo grati e che vogliamo trasmettere alle future generazioni per condividerlo con esse.
Ma, dall’altra parte, questo bene sperimentato non è riuscito a bloccare socialmente i tentativi per trasformare il matrimonio in forme diverse. A questo occorre aggiungere un dato non meno significativo: questo processo è cominciato quando la stragrande maggioranza della legislazione sul matrimonio difendeva la concezione tradizionale derivata dal cristianesimo. Tutta quanta questa legislazione non ha impedito il dilagare di una mentalità contraria al matrimonio, non è stata in grado di arrestare il cambiamento.
Come è potuto succedere? Come è possibile che la chiarezza che si era raggiunta sulla natura del matrimonio e che si era confermata nei secoli nel giro di così poco tempo sia stata messa in discussione in un modalità così generale? Cercare di capire la situazione in corso mi sembra particolarmente decisivo per poter rispondere a essa.
Nella sua ultima enciclica Spe salvi, Benedetto XVI ha offerto una chiave per capire quello che sta succedendo, quando afferma che «un progresso addizionabile è possibile solo in campo materiale. Qui, nella conoscenza crescente delle strutture della materia e in corrispondenza alle invenzioni sempre più avanzate, si dà chiaramente una continuità del progresso verso una padronanza sempre più grande della natura. Nell’ambito invece della consapevolezza etica e della decisione morale non c’è una simile possibilità di addizione per il semplice motivo che la libertà dell’uomo è sempre nuova e deve sempre nuovamente prendere le sue decisioni. Non sono mai semplicemente già prese per noi da altri – in tal caso, infatti, non saremmo più liberi. La libertà presuppone che nelle decisioni fondamentali ogni uomo, ogni generazione sia un nuovo inizio»[1].
Nuovo inizio. Sarà difficile trovare una espressione più adeguata per descrivere il presente. Se ogni momento è un nuovo inizio proprio perché c’è di mezzo la libertà, il nostro è propriamente un nuovo inizio perché quello che era trasmesso pacificamente da una generazione a un’altra non c’è più. È un nuovo inizio perché non si può dare per scontato niente di quello che fino a non poco tempo fa era ritenuto chiaro per tutti. Occorre ricominciare da capo.
A ben guardare la nostra situazione non è molto diversa di quella dell’inizio. Basta ricordare la reazione dei discepoli la prima volta che sentirono Gesù parlare del matrimonio. «Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: “È lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?”. Ed egli rispose: “Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola? Così che non sono più due ma una carne sola Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi”. Gli dissero i discepoli: “Se questa è la condizione dell’uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi”»[2]. Non dobbiamo sorprenderci, quindi. La stessa cosa che a tanti dei nostri contemporanei oggi, e spesso a noi stessi, appare impossibile, tale appariva anche ai discepoli.
Questo non vuol dire che non serva nulla di quanto si è imparato lungo una storia millenaria, ma questa ricchezza accumulata non si trasmette meccanicamente. Prosegue infatti il Papa: «Certamente, le nuove generazioni possono costruire sulle conoscenze e sulle esperienze di coloro che le hanno precedute, come possono attingere al tesoro morale dell’intera umanità. Ma possono anche rifiutarlo, perché esso non può avere la stessa evidenza delle invenzioni materiali. Il tesoro morale dell’umanità non è presente come sono presenti gli strumenti che si usano; esso esiste come invito alla libertà e come possibilità per essa»[3]. La trasmissione in campo morale non è così facile da trasmettere perché i suoi contenuti non possono avere la stessa evidenza delle scoperte scientifiche. Il tesoro morale è un invito alla libertà.
Per questo dobbiamo smettere di sognare «sistemi talmente perfetti che più nessuno avrebbe bisogno di essere buono»[4]. Questo serve prima di tutto a noi che non siamo diversi dai più. Dolorosamente constatiamo come fra noi vi siano molti amici che non riescono a essere saldi di fronte alle numerose difficoltà esterne e interne che attraversano. E quanto a noi, non è sufficiente conoscere la vera dottrina sul matrimonio per resistere a tutte le sfide della vita. Ce lo ha ricordato sempre il Papa: «le buone strutture aiutano, ma da sole non bastano. L’uomo non può mai essere redento semplicemente dall’esterno»[5].
Riguadagnare l’io
Come può dunque accadere questo nuovo inizio auspicato da Benedetto XVI? La strada non può essere altra che quella suggerita dal Faust goethiano: «Ciò che hai ereditato dai tuoi padri, riguadagnatelo, per possederlo»[6]. Per riguadagnarlo occorre riandare all’origine della esperienza amorosa, per riscoprire la sua vera natura. Soltanto questa esperienza può essere adeguato punto di partenza per poter cogliere dall’interno di essa il valore della proposta di Cristo all’amore tra i due sposi.
Gli sposi sono due soggetti umani, un io e un tu, un uomo e una donna, che decidono di camminare insieme verso il destino, verso la felicità. Come impostano il loro rapporto, come lo concepiscono, dipende dall’immagine che ciascuno ha della propria vita, della realizzazione di sé. Ciò implica una concezione dell’uomo e del suo mistero. Afferma il Papa: «la questione del giusto rapporto fra l’uomo e la donna affonda le sue radici dentro l’essenza più profonda dell’essere umano e può trovare la sua risposta soltanto a partire da qui. Non può essere separata cioè dalla domanda antica e sempre nuova dell’uomo su se stesso: chi sono? cosa è l’uomo?»[7].
Per questo il primo aiuto che si può offrire a quanti vogliono unirsi in matrimonio è il prendere coscienza del mistero del loro essere uomini. Solo in questo modo potranno mettere adeguatamente a fuoco la loro relazione, senza attendersi da essa qualcosa che, per sua natura, nessuno può dare all’altro. Quanta violenza, quanta delusione potrebbero essere evitate nel rapporto matrimoniale, se fosse compresa la natura propria della persona!
Questa mancanza di coscienza del destino dell’essere umano conduce a fondare tutto il rapporto su un inganno, che si può sinteticamente formulare così: la convinzione che il tu possa rendere felice l’io. Il rapporto di coppia, in questo modo, si trasforma in un rifugio, tanto desiderato quanto inutile, per risolvere il problema affettivo. E quando l’inganno si manifesta, è inevitabile la delusione perché l’altro non ha compiuto l’aspettativa. Il rapporto matrimoniale non può avere altro fondamento che la verità di ciascuno dei suoi protagonisti.
Come essi possono scoprire la loro verità, il mistero del loro essere uomini?
La dinamica del nuovo inizio: bellezza, segno, promessa
È la stessa relazione amorosa che contribuisce in maniera precipua a scoprire la verità dell’io e del tu; e insieme con la verità dell’io e del tu si manifesta la natura della vocazione comune.
Ciò che siamo ci viene rivelato in maniera solare dalla relazione con la persona amata. Nulla ci risveglia di più, nulla ci rende tanto consapevoli del desiderio di felicità che ci costituisce, quanto la persona amata. La sua presenza è un bene così grande che ci fa cogliere la profondità e la vera dimensione di questo desiderio: un desiderio infinito. Si può applicare per analogia al rapporto amoroso quello che Cesare Pavese dice del piacere: «Ciò che un uomo cerca nei piaceri è un infinito, e nessuno rinuncerebbe mai alla speranza di conseguire questa infinità»[8]. Un io e un tu limitati suscitano l’uno nell’altro un desiderio infinito e si scoprono lanciati dal loro amore verso un destino infinito. In questa esperienza si rivela a entrambi la propria vocazione.
E nello stesso momento in cui si rivelano a noi stessi le dimensioni senza limite del nostro desiderio, ci viene offerta una possibilità di compimento. Più ancora, intravedere nella persona amata la promessa del compimento accende in noi tutto il potenziale infinito del desiderio di felicità. Per questo non c’è nulla che ci faccia comprendere il mistero del nostro essere uomini meglio del rapporto fra un uomo e una donna, come ci ha ricordato Benedetto XVI nella Enciclica Deus caritas est: «l’amore tra uomo e donna, nel quale corpo e anima concorrono inscindibilmente e all’essere umano si schiude una promessa di felicità che sembra irresistibile, emerge come archetipo […], al cui confronto, a prima vista, tutti gli altri tipi di amore sbiadiscono»[9]. In questo rapporto l’essere umano sembra incontrare la promessa che gli fa superare il proprio limite e gli permette di raggiungere una pienezza incomparabile, poiché «alla radice di tutta la realtà vivente c’è la sponsalità. Ed è la sponsalità che rende promessa tutto, come dice la parola stessa: sponsale vuol dire una realtà promettente, che promette»[10]. Per questo la storia dell’umanità – nelle sue pur differenti espressioni – ha sempre istituito una relazione fra l’amore e il divino: «l’amore promette infinità, eternità – una realtà più grande e totalmente altra rispetto alla quotidianità del nostro esistere»[11].
Si tratta esattamente dell’esperienza che in modo indimenticabile esprime Giacomo Leopardi nel suo inno ad Aspasia: «Raggio divino al mio pensiero apparve, | Donna, la tua beltà»[12]. La bellezza della donna è percepita dal poeta come un raggio divino, come la presenza del divino. Attraverso la bellezza della donna è Dio che bussa alla porta dell’uomo. Se l’uomo non comprende la naturalezza di questa chiamata e non rischia nell’assecondarla, difficilmente può comprendere profondamente il proprio destino di infinità e di felicità.
La donna, con il suo limite, desta nell’uomo, anch’egli limitato, un desiderio di pienezza sproporzionato rispetto alla capacità che essa ha di rispondervi. Suscita una sete che non è in condizione di estinguere. Suscita una fame che non trova risposta in colei che l’ha destata. Da qui la rabbia, la violenza, che tante volte sorgono fra gli sposi, e la delusione nella quale vanno a cadere, se non comprendono la vera natura del loro rapporto.
La bellezza della donna è in realtà raggio divino, segno che rimanda oltre, ad altra cosa più grande, divina, incommensurabile rispetto alla sua natura limitata, come descrive Romeo nel dramma di William Shakespeare: «Fammi vedere una donna che sia bellissima fra le altre; | la sua bellezza non sarà altro per me che una pagina | dove leggerò di quella che supera tutto per bellezza»[13]. La sua bellezza grida: «Non sono io. Io sono solo un promemoria. Guarda! Guarda! Che cosa ti ricordo?»[14].
È la dinamica del segno, della quale il rapporto fra l’uomo e la donna costituisce un esempio commovente. Quanto più essi vivono la presenza dell’amato come segno di altro – che è la verità dell’amato –, tanto più essi attendono e bramano questo altro.
Se non comprende questa dinamica, l’uomo cade nell’errore di fermarsi alla realtà che ha suscitato il desiderio. Come se una donna che riceve un mazzo di fiori, rapita dalla loro bellezza, si dimenticasse del volto di chi glieli ha mandati, e del quale sono segno, perdendo il meglio che i fiori recavano. Non riconoscere all’altro il suo carattere di segno conduce inevitabilmente a ridurlo a ciò che appare ai nostri occhi. E prima o poi si manifesta la sua incapacità di rispondere al desiderio che ha suscitato.
Per questo, se ciascuno non incontra ciò a cui il segno rimanda, il luogo dove può trovare il compimento della promessa che l’altro ha suscitato, gli sposi sono condannati a essere consumati da una pretesa dalla quale non riescono a liberarsi, e il loro desiderio di infinito, che nulla come la persona amata desta, è condannato a rimanere insoddisfatto. Di fronte a questa insoddisfazione, l’unica via d’uscita che oggi tanti vedono è cambiare la coppia, dando inizio a una spirale in cui il problema viene rinviato fino al momento della successiva delusione.
Ma entrare in questa spirale non può essere l’unica via d’uscita. Questo è il paradosso dell’amore fra l’uomo e la donna: due infiniti si incontrano con due limiti; due bisogni infiniti di essere amati si incontrano con due fragili e limitate capacità di amare. E solo nell’orizzonte di un amore più grande non si consumano nella pretesa e non si rassegnano, ma camminano insieme verso una pienezza della quale l’altro è segno. Solo nell’orizzonte di un amore più grande si può evitare di consumarsi nella pretesa, carica di violenza, che l’altro, che è limitato, risponda al desiderio infinito che desta, rendendo così impossibile il compimento di sé e della persona amata. Per scoprirlo bisogna essere disposti ad assecondare la dinamica del segno, restando aperti alla sorpresa che questa può riservarci.
Leopardi ha avuto il coraggio di correre questo rischio. Con una intuizione penetrante del rapporto amoroso, il poeta italiano intravede che ciò che cercava nella bellezza delle donne di cui si innamorava era la Bellezza, con la maiuscola. Al vertice della sua intensità umana, l’inno Alla sua donna esprime tutto il suo desiderio che la Bellezza, l’idea eterna della Bellezza, assuma una forma sensibile. È ciò che è accaduto in Cristo, il Verbo fatto carne. Per questo Luigi Giussani ha definito questa poesia come «una profezia dell’Incarnazione»[15].
In questo contesto si può comprendere l’inaudita proposta di Gesù affinché l’esperienza più bella della vita, innamorarsi, non decada sino a trasformarsi in qualcosa di soffocante.
Questa è la pretesa di Gesù, che troviamo in alcuni passi evangelici che a prima vista possono risultarci paradossali. «Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; non sono venuto a portare pace, ma una spada. Sono venuto infatti a separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera: e i nemici dell’uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me; chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato»[16].
In questo testo Gesù si presenta come il centro dell’affettività e della libertà dell’uomo. Ponendo se stesso al cuore degli stessi sentimenti naturali, si colloca a pieno diritto come loro radice vera. In tal modo Gesù rivela la portata della promessa che la sua persona costituisce per quanti lo lasciano entrare. Non si tratta di una ingerenza di Gesù a livello dei sentimenti più intimi, ma della più grande promessa che l’uomo abbia potuto mai ricevere: senza amare Cristo (cioè la Bellezza fatta carne) più della persona amata, quest’ultimo rapporto avvizzisce, perché è Lui la verità di questo rapporto, la pienezza alla quale l’un l’altro si rinviano e nella quale il loro relazione si compie. Solo permettendoGli di entrare in esso è possibile che il rapporto più bello che può accadere nella vita non si corrompa e con il tempo muoia. Tale è l’audacia della Sua pretesa.
Come ha risposto Gesù allo spavento dei discepoli davanti alla verità sul matrimonio che stava loro annunciando? Possiamo dire con una formula: facendo il cristianesimo. Egli non si è fermato ad annunciare la verità del matrimonio, ma ha introdotto una novità nelle loro vite che ha reso possibile viverlo secondo quella verità.
Che questa novità sia qualcosa di così reale e corrispondente alla natura del uomo si vede dal fatto che su di essa si può scommettere tutta la vita. È ciò che la tradizione cristiana chiama verginità.
Matrimonio e verginità
Alla stupita reazione dei discepoli sulla natura originale del matrimonio, che prima abbiamo visto, Gesù oppone una frase che può apparire ancora più enigmatica: «Egli rispose loro: “Non tutti possono capirlo, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Vi sono infatti eunuchi che sono nati così dal ventre della madre; ve ne sono alcuni che sono stati resi eunuchi dagli uomini, e vi sono altri che si sono fatti eunuchi per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca”»[17].
In queste parole Gesù aggiunge una nuova categoria di eunuchi a quelle già note, vale a dire coloro che si fanno eunuchi per il regno dei cieli. Ovviamente si tratta della libera scelta di rinunciare a sposarsi che fanno coloro ai quali è stato concesso di riconoscere il valore unico del regno dei cieli. Commentando questo brano, Giovanni Paolo II ha avuto modo di esprimersi come segue: «nella chiamata alla continenza “per il Regno dei cieli”, prima gli stessi Discepoli e poi tutta la viva Tradizione scopriranno presto quell’amore che si riferisce a Cristo stesso come Sposo della Chiesa e Sposo delle anime, alle quali egli ha donato se stesso sino alla fine, nel mistero della sua Pasqua e nell’Eucaristia. In tal modo, la continenza “per il Regno dei cieli”, la scelta della verginità o del celibato per tutta la vita, è divenuta nell’esperienza dei discepoli e dei seguaci di Cristo un atto di risposta particolare all’amore dello Sposo Divino e perciò ha acquisito il significato di un atto di amore sponsale, cioè di una donazione sponsale di sé, al fine di ricambiare in modo speciale l’amore sponsale del Redentore; una donazione di sé, intesa come rinuncia, ma fatta soprattutto per amore»[18].
Alla luce di questo si capisce cos’è la verginità: il nuovo rapporto assolutamente gratuito che Cristo ha introdotto nella storia. La verginità è vivere le cose secondo la loro verità. E come è entrata nel mondo la verginità? È entrata nel mondo come imitazione di Cristo, cioè come imitazione di vivere di un uomo che era Dio. Nessun altra ragione può sostenere una cosa così grande come la verginità nel vivere l’esistenza, se non l’immedesimazione con la modalità attraverso cui Cristo possedeva la realtà, cioè secondo la volontà del Padre.
La persona di Gesù è un bene talmente grande e prezioso che Egli è l’unico che corrisponde pienamente alla sete di felicità dell’uomo. Proprio questa corrispondenza unica, che la Sua persona costituisce per chi Lo incontra, rende possibile un rapporto col reale assolutamente gratuito. Per questo chi abbraccia la verginità può essere libero per non sposarsi.
Come coloro che sono chiamati alla verginità contribuiscono al regno di Dio? I chiamati alla verginità sono stati scelti perché «gridino davanti a tutti, in ogni istante – tutta la loro vita è fatta per questo – che Cristo è l’unica cosa per cui valga la pena vivere, che Cristo è l’unica cosa per cui valga la pena che il mondo esista. […] Questo è il valore oggettivo della vocazione: la forma della loro vita gioca nel mondo per Cristo, lotta nel mondo per Cristo. La forma stessa della loro vita! […] È una vita che come forma grida: “Gesù è tutto”. Gridano questo davanti a tutti, a tutti coloro che li vedono, a tutti coloro che in loro si imbattono, a tutti coloro che li sentono, a tutti coloro che li guardano»[19].
La vocazione alla verginità è strettamente collegata alla vocazione al matrimonio. Rispondendo alla chiamata i vergini gridano agli sposati la verità del loro amore. Seguiamo ancora Giovanni Paolo II: «Alla luce delle parole di Cristo, come pure alla luce di tutta l’autentica tradizione cristiana, è possibile dedurre che tale rinuncia è ad un tempo una particolare forma di affermazione di quel valore, da cui la persona non sposata si astiene coerentemente, seguendo il consiglio evangelico. Ciò può sembrare un paradosso. È noto, tuttavia, che il paradosso accompagna numerosi enunciati del Vangelo, e spesso quelli più eloquenti e profondi. Accettando un tale significato della chiamata alla continenza “per Regno dei cieli”, traiamo una conclusione corretta, sostenendo che la realizzazione di questa chiamata serve anche – e in modo particolare – alla conferma del significato sponsale del corpo umano nella sua mascolinità e femminilità. La rinuncia al matrimonio per il regno di Dio mette in evidenza al tempo stesso quel significato in tutta la sua verità interiore e in tutta la sua personale bellezza. Si può dire che questa rinuncia da parte delle singole persone, uomini e donne, sia in un certo senso indispensabile, affinché lo stesso significato sponsale del corpo sia più facilmente riconosciuto in tutto l’ethos della vita umana e soprattutto nell’ethos della vita coniugale e familiare»[20].
La verginità è l’autentica speranza per gli sposati; è la radice della possibilità di vivere il matrimonio senza pretesa e senza inganni: «In forza di questa testimonianza, la verginità tiene viva nella Chiesa la coscienza del mistero del matrimonio e lo difende da ogni riduzione e da ogni impoverimento»[21].
«Per questo la verginità è la virtù cristiana ideale di qualsiasi rapporto, anche del rapporto tra un uomo e una donna sposati. E, infatti, il culmine del loro rapporto, il momento culminante del loro rapporto è là dove si sacrificano, non là dove esprimono il loro possesso. Perché, per il peccato originale, di fatto, l’afferrare fa scivolare. È come se uno desidera una cosa e corre verso questa cosa e, quando è lì vicino, corre talmente che vi spacca il naso contro: scivola, incespica. È per questo che noi diciamo che la verginità è un possesso con un distacco dentro»[22]. Il possesso vero che sperimentiamo è un possesso con un distacco dentro.
Il luogo della famiglia: comunità cristiane vive
Appare quindi in tutta la sua importanza il compito della comunità cristiana: favorire una esperienza del cristianesimo per la pienezza della vita di ciascuno. Solo nell’àmbito di questa relazione più grande è possibile non divorarsi, perché ciascuno trova in essa il suo compimento umano, sorprendendo in sé stesso una capacità dì abbracciare l’altro nella sua diversità, di una gratuità senza limiti, di un perdono sempre rinnovato.
Senza comunità cristiane capaci di accompagnare e sostenere gli sposi nella loro avventura, sarà difficile, se non impossibile, che essi la portino a compimento felicemente. Gli sposi, a loro volta, non possono esimersi dal lavoro di una educazione – della quale sono i protagonisti principali –, pensando che appartenere alla comunità ecclesiale li liberi dalle difficoltà. In questo modo si rivela pienamente la natura della vocazione matrimoniale: camminare insieme verso l’Unico che può rispondere alla sete di felicità che l’altro risveglia costantemente in me, cioè verso Cristo. Così si eviterà di passare, come la Samaritana, di marito in marito senza riuscire a soddisfare il proprio autentico desiderio. La coscienza della sua incapacità a risolvere da sola il proprio dramma – nemmeno cambiando cinque volte marito! – le ha fatto percepire Gesù come un bene così desiderabile da non poter fare a meno di gridare: «dammi di quest’acqua, perché non abbia più sete»[23].
Conscio della situazione attuale, Benedetto XVI afferma la necessità «che le famiglie non siano sole. Un piccolo nucleo familiare può trovare ostacoli difficili da superare se si sente isolato dal resto dei suoi familiari e amici. Perciò, la comunità ecclesiale ha la responsabilità di offrire sostegno, stimolo e alimento spirituale che fortifichi la coesione familiare, soprattutto nelle prove o nei momenti critici. In questo senso, è molto importante il ruolo delle parrocchie, così come delle diverse associazioni ecclesiali, chiamate a collaborare come strutture di appoggio e mano vicina della Chiesa per la crescita della famiglia nella fede»[24]. Questo invito pieno di tenerezza e di realismo è allo stesso tempo l’indicazione di un compito: la famiglia come tale abbisogna di un luogo per vivere, ed esso può essere solo costituito da comunità cristiane che a loro volta vivano in pienezza contemplativa e operativa la propria fede. In un intervista Giussani utilizzava la seguente immagine: «Un popolo nasce da un avvenimento, si costituisce come realtà che vuole affermarsi in difesa della sua tipica vita contro chi la minaccia. Immaginiamo due famiglie su palafitte in mezzo a un fiume che si ingrossa. L’unità di queste due famiglie, e poi di cinque, di dieci famiglie, man mano che si ingrossa la generazione, è una lotta per la sopravvivenza e, ultimamente, una lotta per affermare la vita. Senza volerlo, affermano un ideale che è la vita. Così la gente che dice di riferirsi a un popolo reputa inesorabilmente positiva la vita. Per la conoscenza razionalmente impegnata che ho della vita del singolo e della società, queste condizioni dell’idea di popolo toccano il vertice di concezione e di attuazione nell’annuncio del Fatto cristiano, nel quale per noi si compie quello che ha qualificato in tutta la sua storia il grande ethos del popolo ebraico e la sua tensione a cambiare la terra»[25].
L’appartenenza di un essere umano alla propria famiglia si dilata allora nell’appartenenza alla Chiesa, e dunque a quel brandello di Chiesa in cui ognuno di noi sperimenta la presenza universale di Cristo. Lo stringersi fraternamente insieme, il creare dimore ospitali: sono questo il contributo maggiore che i cristiani possono dare per favorire e accompagnare l’esperienza della famiglia come cammino inesausto verso la pienezza costituita da Cristo. «Il superamento della solitudine nell’esperienza dello Spirito di Cristo non accosta l’uomo agli altri, lo spalanca a essi fin dalle profondità del suo essere. […] La comunità diventa essenziale alla vita stessa di ognuno. […] Il “noi” diventa pienezza dell’“io”, legge della realizzazione dell’“io”»[26].
Senza l’esperienza di pienezza umana che Cristo rende possibile, l’ideale cristiano del matrimonio si riduce a qualcosa di impossibile da realizzare. L’indissolubilità e l’eternità dell’amore appaiono come chimere irraggiungibili. E in realtà esse sono frutti tanto gratuiti di una intensità di esperienza di Cristo che agli stessi sposi appaiono come una sorpresa, come la testimonianza che, davvero, «nulla è impossibile a Dio»[27]. Solo una tale esperienza può mostrare oggi la razionalità della fede cristiana, una realtà che corrisponde totalmente al desiderio e alle esigenze dell’uomo, anche nel matrimonio e nella famiglia.
Questa testimonianza è il contributo che possono dare oggi gli sposi cristiani di fronte al travaglio in cui si trovano tanti dei loro concitadini. È una testimonianza gratuita che sfiderà la ragione e la libertà di chi, cercando una autentica risposta alla propria esigenza di felicità, non riesce a trovarla. È una testimonianza che cerchiamo di dare nella consapevolezza che «abbiamo questo tesoro in vasi di creta, perché appaia che questa potenza straordinaria viene da Dio e non da noi»[28].
[1] Spe salvi, 24.
[2] Mt 19,3-6.10.
[3] Spe salvi, 24.
[4] T.S. Eliot, Choruses from “The Rock”, 6 («By dreaming of systems so perfect that no one will need to be good»).
[5] Spe salvi, 25.
[6] J.W. Goethe, Faust, 682-683 («Was du ererbt von deinen Vätern hast, | Erwirb es, um es zu besitzen!»).
[7] Benedetto XVI, Famiglia e comunità cristiana: formazione della persona e trasmissione della fede.
[8] C. Pavese, Il mestiere di vivere, Einaudi, Torino 1973, p. 190.
[9] Deus caritas est, 2.
[10] L. Giussani, Affezione e dimora, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 2001, p. 130.
[11] Deus caritas est, 5.
[12] G. Leopardi, Aspasia, 33-34.
[13] W. Shakespeare, Romeo and Juliet, I, I, («Show me a mistress that is passing fair, | What doth her beauty serve, but as a note | Where I may read who pass’d that passing fair?»).
[14] C.S. Lewis, Sorpreso dalla gioia, Jaca Book, Milano 2002, p. 160.
[15] L. Giussani, Le mie letture, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 1996, p. 30.
[16] Mt 10,34-40.
[17] Mt 19,11-12.
[18] Giovanni Paolo II, Udienza generale, 28 aprile 1982.
[19] L. Giussani, Il tempo e il tempio. Dio e l’uomo, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 1995, pp. 20-21.
[20] Giovanni Paolo II, Udienza generale, 5 maggio 1982.
[21] Familiaris consortio, 16.
[22] L. Giussani, Affezione e dimora, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 2001, p. 250.
[23] Gv 4,15.
[24] Benedetto XVI, Incontro festivo e testimoniale per la conclusione del V Incontro Mondiale delle Famiglie.
[25] L. Giussani, L’io, il potere, le opere. Contributi da un’esperienza, Marietti, Genova 2000, p. 251.
[26] L. Giussani, Il cammino al vero è un’esperienza, Rizzoli, Milano 2006, p. 110.
[27] Lc 1,37.
[28] 2Cor 4,7.
“Famiglia: un’esperienza positiva in atto ”
Meeting di Rimini, Mercoledì, 22 agosto 2007, ore 19.00
Partecipano:
Eugenia Roccella, Giornalista e Scrittrice; Jimmy Garbujo, di Associazione Famiglie per l’Accoglienza: Emilio Gobbi, di Associazione Fraternità di Crema; Caterina Tartaglione, Presidente del Sidef.
Moderatore:
Alberto Savorana, Direttore di Tracce
MODERATORE:
Diceva Don Giussani: “Perciò la preoccupazione educativa di una famiglia è intelligente e umana nella misura in cui si rassegna ad uscire da un comodo anche meritato, per stabilire rapporti che creino una trama sociale che si opponga alla trama sociale dominante”. Sono parole scritte nel 2000, ma che conservano e aumentano la loro carica di attualità e di pertinenza alla situazione presente. Proprio per questo noi abbiamo voluto mettere a tema al Meeting la famiglia, offrendo innanzitutto tre testimonianze, tre contributi cui abbiamo chiesto ad Eugenia di reagire, giudicandoli, commentandoli e a partire da questi esporre il suo punto di vista, come lei in questo momento preciso vede la situazione e la sfida che ci attende per il futuro. Abbiamo voluto offrire tre contributi positivi, perché come aveva scritto Giancarlo Cesana, all’indomani del Family Day, “San Giovanni in Laterano è stato una sorpresa” perché è stata la sorpresa di uomini e donne, di famiglie, per i quali la tensione alla verità della propria umanità e la tensione alla verità del proprio rapporto affettivo verso il destino, sono una cosa che interessa. E’ stata una novità di un popolo, di un popolo di famiglie, dal quale la sfida attuale è sentita come personale ed è condivisa. Allora noi abbiamo invitato tre persone che, a diverso titolo, partecipano, si dedicano a tre realtà di ambito familiare, tutte e tre nate all’interno dell’esperienza di Comunione e Liberazione. Caterina Tartaglione del Sindacato delle famiglie, Jimmi Garbujo delle Famiglie per l’Accoglienza ed Emilio Gobbi dell’Associazione Fraternità di Crema. Al termine delle loro tre testimonianze, io darei la parola ad Eugenia che reagirà a caldo a quello che avrà ascoltato e poi ci dirà come lei percepisce la situazione del momento e la sfida del futuro.
CATERINA TARTAGLIONE:
Buonasera a tutti, ringrazio gli amici del meeting per questa opportunità che ha permesso a me e alla mia famiglia di ripensare alla nostra esperienza. Non è facile concentrare in pochi minuti quasi 30 anni di vita matrimoniale. Sono infatti così tanti gli avvenimenti e le persone che ne hanno segnato il percorso, facendone gli argini e le sponde, permettendo a ciò che abbiamo vissuto in questi anni di non essere disperso in frammenti isolati, ma di formare anelli legati insieme a comporre la nostra storia. Storia in cui nulla è andato perduto.
L’inizio è sempre determinante perché contiene già tutto lo svolgimento futuro, dal sì iniziale, dalla promessa di fedeltà pronunciata nel sacramento del matrimonio, è scaturita una tale grazia da permetterci di dire: “ne è valsa la pena o meglio, oggi ne vale la pena”.
L’inevitabile impegno che questa scelta comporta è per una pienezza umana, per una vita nuova, buona, dove si rivela una possibilità di felicità non solo per noi ma anche per tutte le persone che incontriamo.
Ciò che ha permesso questa unità tra noi, così diversi e ha legato tutti gli avvenimenti vissuti,anche dolorosi, è stato intravedere che c’è un nesso fra tutte le cose, un significato, una verità sottesa per cui io e mio marito stiamo insieme e rende positivo ciò che viviamo.
Il primo sentimento per noi è quello di una profonda gratitudine a chi ci ha consegnato questa verità, don Giussani, incontrato fin dai tempi dell’università e che ha acceso i nostri cuori e ci ha affascinati, permettendoci di amare con ragionevolezza la Chiesa che da sempre custodisce questa verità in una compagnia di uomini, luogo e presenza di Cristo.
Il secondo punto che ci ha accompagnati nel cammino è la frase che don Giussani ci ha affidato, nell’omelia del nostro matrimonio: “Ricordatevi che è per un compito”.
Questa frase da subito ci ha interpellati anche se all’inizio non abbiamo capito. Lo stiamo comprendendo strada facendo, crescendo nell’esperienza del movimento di Comunione e Liberazione dove siamo stati educati ad avere uno sguardo sulla persona, senza pretendere che l’altro sia la risposta esauriente al desiderio di felicità e anche dopo tanti anni di matrimonio è un’educazione continua. Ci siamo accorti così che il rapporto maturando non può avere diverso fondamento che la verità di ciascuno. In questa esperienza infatti si rivela ad entrambi la propria vocazione.
Per noi vivere il matrimonio vuol dire camminare insieme verso Cristo, l’Unico capace di rispondere alla sete di felicità che l’altro suscita costantemente in noi. Così ci scopriamo capaci di abbracciare la diversità ed i nostri limiti, perdonandoci.
Questo avviene perché, noi per primi, siamo stati accolti, sostenuti e sorretti nell’affronto della vita quotidiana, in modo totalmente gratuito, dalla compagnia di tanti amici ai quali siamo legati in maniera indissolubile. In particolare per noi è stata l’amicizia con i Memores Domini della casa di Gudo, con la famiglia di Buccinasco che ha ospitato per anni mia figlia, quando in prima liceo ha deciso di fare un’esperienza di più ampio respiro andando a studiare a Milano. In questa situazione per noi di sofferenza e preoccupazione Don Giussani ci ha tranquillizzati dicendoci. “Affidatela a questi amici, è come se fosse con voi“. Abbiamo sperimentato così la solidarietà di un’altra famiglia e iniziato un cammino comune educativo, dove siamo stati educati noi insieme ai nostri figli. Queste persone sono per noi l’abbraccio concreto di Cristo: un dono, una grazia che ci accompagna costantemente.
C’è qualcosa di più grande su cui tutta la famiglia si regge ed è unita, al di là degli inevitabili errori che si possono fare. E’ una certezza che cerchiamo di trasmettere ai nostri figli, più importante del lavoro, dei soldi, dei successi personali: è il desiderio di bene l’uno per l’altro .
Per me l’altra esperienza fondamentale è che la famiglia è proprio il luogo della libertà perché introducendo proposte e non dubbi permette ai miei figli di confrontarsi, di esercitare cioè la loro capacità di giudizio. Non è un rapporto a senso unico, anche noi genitori siamo educati ad essere liberi dallo schema fatto sui figli: normalmente infatti le loro decisioni spiazzano e rompono i miei progetti.
Tutto questo l’abbiamo imparato nel tempo, non astrattamente ma da una presenza concreta, una compagnia che già negli anni dell’Università, a Milano, non si tirava indietro nel giudicare tutto ciò che accadeva, in un periodo in cui non era facile affermare la propria appartenenza alla Chiesa.
Questi stessi amici 25 anni fa hanno proposto a me e a mio marito di iniziare a Pesaro il Sindacato delle Famiglie e l’idea ci piacque subito, ci corrispondeva. C’è sembrata un’occasione per approfondire l’essere famiglia con tutto ciò che comportava: l’inizio del lavoro, l’educazione dei figli, il desiderio di continuare a vivere l’esperienza incontrata.
Sono stati coinvolti, in questa avventura, gli amici più prossimi e anche alcuni pazienti (siamo 2 medici).
La presentazione come Sindacato è coincisa con la prima battaglia intrapresa per avere a Pesaro un nuovo acquedotto che la città attendeva da 30 anni. Le famiglie erano costrette ad acquistare acqua minerale con una notevole spesa economica: quella volta abbiamo raccolto in piazza più di 3.500 firme, organizzato assemblee pubbliche e sicuramente il nostro coinvolgimento ha contribuito a sollecitare la costruzione dell’attuale acquedotto.
Questo giocarsi in prima persona è stato determinante nel far crescere in noi una consapevolezza nuova, più matura, dove la vocazione personale è passata attraverso la condizione di sposi, e si è delineata anche come responsabilità ed impegno personale nella costruzione di quest’opera.
Siamo stati sostenuti dall’amicizia con Peppino Zola e la moglie Adriana, fondatori del Sidef, con Paola Soave per tanti anni alla guida dell’opera, dagli incontri con i responsabili e dai rapporti con gli amici delle varie sedi locali in cui via via ha preso vita e si è articolato il Sidef .
Questa capacità di coinvolgimento, cercando di apprezzare il positivo presente nell’altro, ha fatto nascere una vastissima trama di rapporti e di amicizie, facendo accrescere la stima da parte di tante persone di altre associazioni e movimenti, in particolar modo degli amici del Forum. La cordialità e la “simpatia” per l’uomo, imparate continuamente nel Movimento, sono fondamentali nell’incontro con gli altri e nella condivisione dei loro bisogni.
Così ci ha incoraggiati Don Giussani nel 1993 durante un incontro con i responsabili del Sidef, determinante per ognuno di noi. Ci ha detto: “ se questo assetto della famiglia con i riferimenti originali su cui si appoggia non è difeso socialmente, il fenomeno si deprime, viene soverchiato e schiacciato. Questa è una carità per tutta la società che permane”.
Le sue parole ci hanno sostenuto e accompagnato in ogni tipo di iniziative sociali e politiche, a livello sia locale che nazionale.
Abbiamo difeso pubblicamente la realtà famiglia là dove è stata minacciata o non riconosciuta o anche sottilmente ostacolata perché considerata non determinante per lo sviluppo della società. Spesso a parole ne viene sottolineato il valore, ma nei fatti la società attuale vuole l’uomo solo, sganciato da questa prima esperienza di socialità che è la famiglia, per renderlo più manipolabile dal potere.
Il Family Day è stato il frutto di una coscienza nata da un lavoro comune.
Da 3 anni, per lo stesso motivo, ho accettato di fare il Consigliere Comunale in una lista civica. Il punto discriminante per accogliere questo ulteriore impegno è stato di evidenziare sempre più nel sociale i giudizi e le proposte emergenti dalla nostra originale esperienza e dall’ amicizia fraterna che vivo con chi a Pesaro costruisce il Sindacato insieme a me. La nostra forza e la nostra presenza pubblica in città nascono da questa unità, così pure le battaglie fatte in Comune per la difesa, ad esempio, delle convenzioni per le scuole paritarie o per un fisco più equo a misura di famiglia. Mi ha colpita lo stupore di un consigliere di maggioranza che mi ha detto: “Si vede che ami quello che dici, che ci credi e anche se sono dall’altra parte ho votato per la tua mozione”.
Un modo di vivere così chiede e da’ ragioni confrontabili con ogni posizione perché al centro, in ogni caso, c’è la persona con tutti i suoi desideri: da questo riconoscimento è possibile una costruzione comune.
Io e la mia famiglia, non possiamo che essere riconoscenti a chi ci ha insegnato a vivere così, a chi ci insegnato innanzi tutto le ragioni del compito ma anche il gusto, la libertà, la passione e quella ingenua baldanza che ci permette di affrontare senza timore la realtà.
MODERATORE:
Si vede che ami quello che dici. Solo l’esperienza di un grande amore, cioè di una passione convincente e avvincente mette in moto, mette in azione, fa cercare solidarietà aiuti per portare la battaglia della verità. Adesso ascoltiamo Jimmi Garbujo della Famiglie per l’accoglienza.
JIMMI GARBUJO:
Grazie. Io sono sposato da anni con Silvia. Abbiamo quattro figli. La nostra è una storia molto semplice e piena di gratitudine. Un anno dopo il matrimonio abbiamo incontrato subito, venendo da fuori, alcune famiglie che facevano accoglienza. Ne è nata un’amicizia inaspettata, intensa, gratuita che mi ha portato qui. E soprattutto questo rapporto ci ha aiutato ad approfondire l’esperienza di Comunione e Liberazione che avevamo incontrato proprio con queste famiglie. Ma la cosa che ha colpito me e mia moglie da subito era stata la passione con cui questa gente viveva la normalità della vita, ogni aspetto della vita quotidiana. Ci veniva detto: “stateci vicino, la vostra amicizia per noi è preziosa” e sinceramente noi non capivamo in che cosa eravamo preziosi, ma ci siamo stati perché ci interessava imparare quello sguardo per cui la realtà è sempre da abbracciare perché è sempre interessante. Di fatto per noi la sfida in quegli anni è stata sulla normalità della vita quotidiana della nostra famiglia, cioè imparare a desiderare che le solite cose diventassero occasione di una novità e di uno stupore per noi e per i quattro figli che via via sono arrivati. Vi sto parlando di un periodo che è durato circa dieci anni. Era inevitabile che ad una certo punto io e mia moglie ci domandassimo: “Ma noi, non accogliamo nessuno?” Era come un dubbio, anzi una pretesa ultima che mettevamo su ciò che stavamo vivendo. La domanda era sorta perché avevamo partecipato alla nascita dell’Associazione Famiglie per l’Accoglienza in Veneto. Ma questi amici ci facevano notare che i nostri figli e i ritmi familiari ancora forse non permettevano un’accoglienza. Allora dopo anni, ripensando a tutte queste vicende, ho capito un po’ di più ciò che Don Giussani, proprio alla prima pagina de “Il miracolo dell’ospitalità”, dice: “State all’erta, vigilate, siate coscienti del vostro rapporto con Dio”. E due o tre pagine dopo: “non possiamo spalancare la nostra presenza ad accogliere la presenza di un altro se innanzitutto noi non ci sentiamo accolti”. Guardando queste famiglie, stando con loro, abbiamo imparato a coinvolgerci con la nostra vita, a guardarla con meno ansia e pretesa, più tesi a riconoscere questa paternità e ciò che è accaduto a noi è un’esperienza che capita spesso nella nostra Associazione, cioè la famiglia che accoglie e le famiglie vicine che collaborano e aiutano, crescono nell’umanità allo stesso modo, perché respirano la stessa aria, perché partecipano dello stesso bene. Ecco, perché in Italia a fronte di più di 500 gesti di accoglienza che esistono all’interno della nostra Associazione, ci sono iscritte più di 6000 famiglie. Poi quando meno te l’aspetti accadono dei fatti. Ne racconto due brevemente. Il primo: durante una vacanza in montagna, una ragazza ci propone di accogliere una mamma con un ritardo psichico. E’ stata da noi sei mesi. A questa donna erano stati tolti i figli, era stata abbandonata dal marito, quindi una situazione pesante. Tuttora lei fa parte della nostra famiglia, anche se non è più con noi e sin dal primo giorno, ma anche adesso, quando è in un momento di fatica, telefona a mia moglie e dice: “Ma tu mi vuoi bene?” Questa cosa ci ha sempre aiutato a far memoria del “Pietro, mi ami tu?” e quindi ci ha aiutato a ricentrare sempre lo sguardo su di noi, su lei, l’accolta e anche sui nostri figli. Secondo fatto: sempre una persona adulta. Al sabato sera arriva la fatidica telefonata. Quest’uomo viene a casa nostra, sta lì tre giorni. Il secondo giorno comincia a raccontarci la sua storia, pesantissima e comincia a recriminare sull’ingiustizia che c’è nel mondo, sulla sfortuna che lui ha avuto. Io e mia moglie eravamo lì, sperando che i figli non ascoltassero, e gli abbiamo detto: “Noi non sapevamo nulla di te e ti abbiamo accolto in casa, di questo non puoi non tenerne conto”. Ma gli dicevamo questo per ricordare a noi proprio che l’ultima parola sulla vita non è la fatica o la sfortuna ma è l’esperienza di misericordia e gratuità che il Signore ci fa fare, di cui però purtroppo ci dimentichiamo spesso. E veniamo all’oggi. Due anni e mezzo fa circa, il funzionario responsabile della Tutela Minori della nostra Als chiede all’Associazione Famiglie per l’Accoglienza una famiglia per entrare in una casa di accoglienza. Lui chiedeva una famiglia che avesse un po’ di esperienza di accoglienza ma soprattutto che fosse all’interno di una storia, all’interno di una compagnia di famiglie. Quindi aveva scelto la storia della nostra associazione. E’ cominciata la ricerca di una famiglia, ma la cosa non era semplice e l’elenco che avevamo scritto si è subito esaurito, perché bisognava trasferirsi, traslocare. E una bella mattina io e mia moglie ci siamo guardati e ci siamo solo detti: “E noi?”. Non abbiamo analizzato, non abbiamo soppesato, non abbiamo calcolato i rischi, anche se dopo sono tutte cose da affrontare. Ma ciò da cui siamo partiti è: “Perché no?”. E con questo “perché no?” siamo andati da questi nostri amici, quelli che a suo tempo ci avevano aiutato a dire di no. Solo che questa volta tutti, dal primo all’ultimo, facevano il tifo per noi. Quindi ad aprile di quest’anno, sabato santo, prima di Pasqua, siamo entrati in questa nuova casa. “La vocazione – dice Don Giussani – si presenta più come una possibilità intravista che come ineluttabilità inequivocabile e questo è un bene, perché ci aiuta a non essere presuntuosi e a chiedere sempre”. Ma c’è un’altra questione. Ma come può la vita continuare a corrispondere anche quando le circostanze cambiano in maniera così eclatante? Noi ce lo chiediamo spesso perché è una questione che vogliamo capire bene. Perché vogliamo capire bene che cosa ci sta succedendo. Perché sinceramente i primi ad essere stupiti di questa cosa qui siamo noi. La risposta che abbiamo intuito è questa: la corrispondenza c’è laddove uno è in gioco con la propria umanità. E questa è la posizione che abbiamo imparato guardando molti di voi qui presenti: vivere la propria vita semplice, straordinariamente normale eppure così affascinante. Siamo stati proprio educati, dobbiamo riconoscerlo, ad essere in gioco, a stare in gioco dentro la realtà e ad affidarci alla storia in cui il Signore ci ha messo, perché questo, l’abbiamo sperimentato più volte, ci permette di ricominciare sempre. Giussani dice che non c’è gratuità autentica se non si vive con gratitudine la carità con cui Cristo ha toccato la nostra vita attraverso l’esempio di altri e senza la fedeltà a questa compagnia, la nostra carità non farebbe storia. Non sarebbe possibile concepirsi da soli. Diceva prima il dottor Savorana: “non si può resistere da soli”. Il nostro sì non ci sarebbe stato se non ci fossero stati i sì di tanti di voi qui presenti e a casa. Un esempio eclatante è questo. Questa nostra casa nuova, noi l’abbiamo potuta vedere la prima volta cinque minuti per capire se ci stavamo dentro e la seconda volta dopo sei mesi per prendere le misure, perché questa casa era abitata. Ma questa seconda volta io ho ben presente lo scompenso che mi ha preso, perché io sono salito e ho detto: ho sbagliato, non ci stiamo. Qui i nostri figli non possono dormire. Non c’è lo spazio che avevo visto la prima volta. Però ho anche presente che cosa è successo subito dopo. Perché vicino a me c’era un architetto, sua moglie arredatrice e un amico artigiano che mi hanno detto: “Tu parla con i funzionari del Comune e dell’Asl. Qui viene fuori una bella cosa.” E hanno cominciato a prendere le misure su dove aprire le finestre, su dove fare le pareti nuove. La gratuità genera altra gratuità. Questo è una spettacolo che allarga il cuore. Non eravamo soli e non siamo soli. Quindi sì, si poteva fare, si può continuare anche oggi. Attualmente abbiamo due brave ragazze adolescenti con noi, un terzo arriva la settimana prossima e poi ne arriveranno anche altri. Ai nostri figli come garanzia abbiamo detto questo: “Guardate che il papà e la mamma non hanno mai avuto il pallino di una casa famiglia. Ci siamo stati perchè abbiamo riconosciuto ciò che il Signore ci ha messo davanti. Stateci anche voi come siete e vedrete che sarà adeguato per tutti. Certo a loro chiediamo una bella fatica, perché che le nostre case diventino una dimora per altre persone non è facile. Ma si chiede poco a chi si stima poco e si chiede tanto a chi si stima tanto. A volte il preservare i nostri figli dalle fatiche è segno di non stima. Loro se ne accorgono subito. Abbiamo visto che dentro all’esperienza quotidiana della giornata anche i nostri ragazzi si accorgono di essere capaci di accogliere e questo bene che vivono li rilancia, dà loro una sicurezza, hanno più stima di loro stessi. E’ proprio vero che tanto più uno ama tanto più è se stesso. Questa nostra casa l’abbiamo chiamata “San Benedetto”, perché siamo stati sempre affascinati dalla figura di questo Santo, dalla sua storia, dalle sue opere e perché abbiamo conosciuto alcuni monaci. Anche perché ci ha sempre colpito quella frase del Salmo 33, che è stato un titolo del Meeting, che è all’inizio della regola e dice: “C’è qualcuno che desidera la vita e vuole vivere giorni felici?” Sì, noi lo desideriamo, desideriamo rispondere con questo semplice sì. Perché nel dire di sì ci siamo accorti che ci sentiamo preferiti. Un’ultima sottolineatura sulla bellezza, perché siamo andati a vedere delle case di accoglienza e la cosa che ci ha colpito, che accomunava tutte, era la bellezza. Subito. Una bellezza che ti lascia senza fiato, che ti commuove, che ti fa chiedere: “ma come è possibile una cosa del genere? Questi devono accogliere e guarda che cosa fanno!” e dopo abbiamo conosciuto le persone che c’erano dentro e abbiamo visto che le cose belle sono perché ci sono le belle persone che hanno una passione per la vita e la bellezza esprime la concezione della vita che hanno queste famiglie. Bene, anche da noi ci sono tanti lavori da fare. Tanti si sono coinvolti seriamente in quest’opera. Desideriamo veramente che i lavori portino a questo concetto di bellezza: come è bello il mondo e come e grande Dio! Concludo leggendovi un’ultima citazione di Don Giussani, che un amico mi ha mandato il giorno dell’inaugurazione: “Non c’è nulla che rende più fecondi, più pazienti, più capaci di perdono, più capaci di attesa che mettere il piede dove l’ha messo un altro” Questa è la grazia più grande della nostra amicizia. Il tempo in questa sequela renderà ragionevole e renderà pieno di letizia ogni passo della vita, persino quelli carichi di profonda drammaticità e di dolore. Grazie.
MODERATORE:
E noi? La domanda che Jimmi e sua moglie si sono posti quel giorno vale anche per ciascuno di noi. E noi dove siamo? Il titolo del Meeting ci riguarda? Mi riguarda? Perché sono io che desidero la verità e sono io che voglio compiere la strada verso il destino. Questo desiderio, oggettivo, che trovo dentro la struttura del mio essere, lo voglio abbracciare? Voglio diventare protagonista? E senza questo non si spiega nessun tentativo umano e sicuramente anche il Family Day
EMILIO GOBBI:
Buonasera a tutti. E’ per una gratitudine al buon Dio, e solo per questo, che sono qui a raccontarvi il miracolo di ciò che Dio ha compiuto nella mia vita e nella mia famiglia. Mi chiamo Emilio Gobbi, ho 45 anni, e sono sposato con Antonella da 21. Abitiamo a Crema da quando abbiamo incontrato l’esperienza dell’Associazione “Fraternità”, fondata e guidata da Monsignor Mauro Enzoli. Da 17 anni accogliamo in casa nostra minori e non solo, in difficoltà familiare o con problemi di salute. Fino ad oggi abbiamo ospitato più di 20 ragazzi, chi per pochi giorni, chi per anni e chi, come Gianluca, abbiamo accompagnato a morire. In questo momento abbiamo nove figli, quattro generati, uno adottato e quattro in affido e da più di un anno sono parte della nostra famiglia anche Maria, una ragazza madre, e sua figlia Arianna. Noi abbiamo iniziato la nostra esperienza di accoglienza mossi dal desiderio che era presente fin da quando eravamo fidanzati: fare della nostra famiglia qualcosa di grande, qualcosa che rimanesse nel tempo. Ci aveva affascinato la frase di Giovanni Paolo II che avevamo riportato sulla nostra partecipazione di nozze: “Costruite la civiltà dell’amore”. Nel ’88 eravamo in vacanza alle vacanzine del Movimento, a Corvara, e con la nostra comunità c’era anche un gruppo delle famiglie per l’accoglienza. Lì abbiamo conosciuto la signora Pia che aveva adottato un bambino down. Immediatamente, e questa è una cosa che ci ha sempre accompagnati nel tempo, abbiamo percepito una istintiva corrispondenza tra quell’incontro, tra il gesto di accoglienza della signora Pia verso il bambino down, e il nostro desiderio. Siamo rimasti profondamente attratti dalla forma di vita che abbiamo incontrato, e quindi abbiamo deciso di cominciare a frequentare le famiglie per l’accoglienza. Era ottobre e abbiamo iniziato a recitare il Santo Rosario tutte le sere e questo ci ha accompagnato fino ad oggi. E abbiamo chiesto alla Madonna che si compisse questo nostro desiderio. Una sera, durante un incontro del gruppo affido, è stato dato l’avviso che a Bari c’erano tre bambini down abbandonati in un istituto. Avevamo veramente un sacco di motivi per far finta di non aver sentito quell’avviso. Io, in quel momento, per esempio, non avevo il lavoro. Ma di botto, istintivamente, ci venne spontaneo dare la nostra disponibilità, affidando, come sempre, alla Madonna tutte le nostre obiezioni e pensando che comunque ci sarebbero state molte altre famiglia più adeguate. Ma incredibilmente eravamo gli unici! E così Fabrizio, bambino di tre anni allora e ragazzo di venti oggi, è arrivato a casa nostra quattro giorni prima di Natale. L’incoscienza con cui abbiamo detto di sì a Fabrizio è stata segno della nostra personale vocazione. Nel 1992 Don Mauro ci ha proposto di andare ad abitare in una casa di accoglienza che l’associazione Fraternità aveva appena ottenuto in comodato d’uso. Siamo rimasti anche noi affascinati dalla bellezza delle case di accoglienza di cui si diceva, ma soprattutto perché la casa era molto molto più grande allora, perché oggi è piccola per noi, rispetto alla casa dove vivevamo a Milano. E quindi abbiamo detto di sì per questo. E perché la casa aveva veramente un grande giardino che noi a Milano nemmeno avremmo potuto immaginare. Però i primi anni di accoglienza a Crema, per noi, sono stati veramente molto, ma molto, faticosi, perché eravamo in rapporto con i nostri figli, naturali ed affidati, secondo la nostra misura. Con la nostra smisurata pretesa che loro diventassero migliori e per migliori intendo l’eliminazione del limite che ci caratterizza, ed anche con la forte presunzione di essere noi capaci di rispondere al loro bisogno. Ma in quei momenti, come sempre, Don Mauro ci è stato molto vicino, e veniva spesso a trovarci, (cosa ad oggi meno frequente perché è così impegnato) e la sua amicizia è stata per noi quella di un padre, che non si pone il problema di fare dei discorsi quando il figlio è in difficoltà, ma che lo sa guardare con stima, al di là della sua evidente miseria e meschinità. Don Mauro ci ha sempre sostenuti, senza mai rimproverarci per i nostri ripetuti errori, e ha continuato a riporre la sua fiducia in noi, chiedendoci nuove disponibilità per ospitare nuovi ragazzi. E così, pian pianino, imitando lo sguardo che Don Mauro ha avuto e ha su di noi, che non è altro che il riverbero dello sguardo commosso e misericordioso di Dio sull’uomo, abbiamo finalmente sacrificato l’autonomia del nostro criterio, abbiamo messo da parte la pretesa e abbiamo iniziato, almeno come tentativo, a servire il bisogno dei nostri figli e a scommettere totalmente sulla loro libertà, sempre chiedendo al buon Dio di fare Lui. Abbiamo iniziato a perdonarci tra di noi: dopo ogni sbaglio, nostro e dei nostri figli, è ora possibile chiedere perdono e c’è il miracolo che l’altro ti dica: “andiamo avanti!”. C’è la possibilità di fidarsi nuovamente e di ricominciare: “Hai sbagliato ed io mi fido ancora di più”. E questo, vi assicuro, è stata una svolta notevole per la nostra famiglia. Tanto è che ora, dire a un ragazzo accolto: “Io non ti lascio, non ti lascerò mai”, mentre lo contieni perché questo altrimenti spacca tutto, come ci è successo, e malmena i tuoi figli, mentre magari ti piscia addosso, ti sputa e ti picchia, è possibile solo per quello che ci insegna Don Giussani: il valore della persona, il rapporto diretto ed esclusivo che ha con Dio, come ci ha ricordato anche Carron agli ultimi Esercizi della Fraternità. Ciò che ce lo fa dire – e questa per noi è stata proprio una sorpresa perché chi ci conosce sa che noi non siamo esattamente l’esempio di pazienza o di bontà o di dolcezza: chi passa sotto casa mia sente sempre me e mia moglie urlare come degli ossessi! – non è la nostra capacità ma il riconoscimento che noi per primi siamo stati trattati così dal buon Dio, da Don Mauro, dai nostri amici e da questo grande popolo cristiano di cui facciamo parte. Dei vari ragazzi ospitati a casa nostra, vorrei raccontare brevemente le esperienze con Gianluca e Arianna. Quattro anni fa è stato chiesto all’Associazione Fraternità la disponibilità ad accogliere un neonato gravemente cerebroleso. Una sola famiglia ragionevolmente non ce l’avrebbe fatta a provvedere a Gianluca. Ma l’osservazione della realtà e la genialità educativa di Don Mauro hanno consentito di individuare una modalità di risposta adeguata. Gianluca di tre mesi è stato accolto dalla nostra famiglia e da altre due famiglie di nostri amici. Ognuno di noi aveva cura di Gianluca nella propria casa per 2 giorni e mezzo alla settimana. Le nostre tre famiglie e il popolo dei nostri amici hanno accompagnato Gianluca all’età di 10 mesi all’incontro con Gesù, dopo averlo vegliato notte e giorno nella sua agonia per settimane. Questa esperienza ha realmente cambiato noi e i nostri amici, perché è stata come un miracolo di unità e di carità imprevista, che ha travolto i muri delle nostre resistenze, come ci ha ricordato Don Mauro durante il funerale di Gianluca: “La vostra forza è stata la vostra unità, diventata anche la vostra amicizia. Quello che da soli nessuno avrebbe potuto portare e sopportare, è